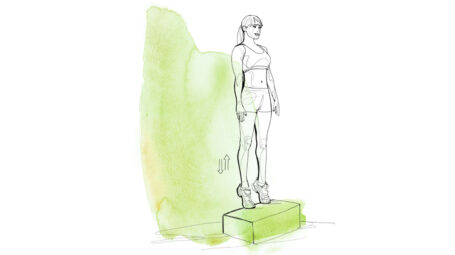Tendinite dell’Achille: cos’è, cause, sintomi, cure
Questa condizione colpisce sia sportivi sia sedentari e può evolvere fino alla rottura del tendine di Achille. La diagnosi si basa sull’esame clinico e sull’imaging, mentre il trattamento combina fisioterapia, esercizi specifici e, nei casi gravi, intervento chirurgico

È una delle strutture più potenti del corpo umano, ma anche una delle più vulnerabili. Il tendine d'Achille, solido collegamento tra i muscoli del polpaccio e il calcagno, sostiene ogni movimento del piede, trasformando la forza in slancio. Quando inizia a far male, a irrigidirsi o a gonfiarsi, raramente si tratta di una semplice infiammazione.
Negli ultimi decenni la ricerca ha rivoluzionato la comprensione di queste patologie. Quella che un tempo era definita “tendinite” è oggi riconosciuta come tendinopatia: un disturbo in cui il tendine d'Achille perde la capacità di rigenerarsi in modo efficace. Non è più l’infiammazione il vero nemico, ma un difetto nei processi di guarigione che, in modo silenzioso e progressivo, ne altera la struttura e ne compromette la funzione.
Ecco cos'è la tendinopatia non-inserzionale del tendine d'Achille.
Cos’è la tendinopatia non-inserzionale dell'Achille
«La tendinopatia non-inserzionale interessa la porzione centrale del tendine d’Achille, circa quattro-sei centimetri sopra il punto in cui si inserisce sul calcagno», spiega il professor Nicola Maffulli, primario della U.O.C. di Clinica Ortopedica presso l’Azienda ospedaliero-universitaria Sant’Andrea di Roma e professore ordinario di Ortopedia e Traumatologia alla Sapienza Università di Roma.
«È in questa zona che si concentra la triade tipica della patologia: dolore, gonfiore e alterazioni visibili agli esami strumentali come l’ecografia o la risonanza magnetica».
Non si tratta di una vera infiammazione, ma del segno di un tendine che tenta di ripararsi senza successo. Le fibre, sottoposte a sollecitazioni ripetute, entrano in un processo di guarigione imperfetta che, nel tempo, altera la struttura del tessuto e ne riduce la capacità di sopportare il carico. In altre parole, il tendine non è “malato” perché infiammato, ma perché stanco e disorganizzato nella sua stessa architettura biologica.
Quali sono le cause della tendinopatia non-inserzionale dell'Achille
Le origini di questa patologia sono molteplici, ma spesso riconducibili a un utilizzo eccessivo del tendine. L’overuse, cioè il sovraccarico funzionale dovuto a gesti ripetuti come corsa, salti o balzi, rappresenta la causa più comune nei soggetti sportivi. «Tuttavia oggi i casi più difficili da trattare riguardano le persone sedentarie o in sovrappeso, nelle quali la tendinopatia si intreccia con alterazioni del metabolismo, in particolare diabete e dislipidemie», evidenzia il professor Maffulli.
Non mancano poi correlazioni con patologie sistemiche come l’ipotiroidismo e l’iperuricemia, fino alle forme osservate nel periodo post-Covid, quando si è registrato un incremento di pazienti affetti pur in assenza di fattori di rischio evidenti.
A tutto questo si aggiunge una componente genetica non trascurabile: alcune persone sembrano infatti predisposte per natura a sviluppare la malattia, ereditando dai familiari una maggiore vulnerabilità del tessuto tendineo.
Quali sono i sintomi e come si diagnostica
Il primo campanello d’allarme è quasi sempre il dolore. I pazienti descrivono una sensazione di fastidio o rigidità nella parte posteriore della gamba, a pochi centimetri sopra il tallone. Spesso il dolore è più intenso al risveglio, per attenuarsi dopo i primi movimenti e riapparire durante l’attività fisica o al termine di uno sforzo prolungato. Nei casi più gravi, la capacità del tendine di sopportare il carico può ridursi fino a portare a una rottura improvvisa, accompagnata da un dolore acuto, paragonabile a una frustata, e dall’impossibilità di camminare sulla punta del piede.
«La diagnosi resta principalmente clinica: è l’osservazione diretta e l’esame obiettivo del medico a fornire le informazioni decisive», dice l’esperto.
«Gli strumenti di imaging, come l’ecografia ad alta risoluzione o la risonanza magnetica, servono a confermare la diagnosi, ma non la sostituiscono. Un dato curioso e spesso sorprendente è che un tendine può apparire gravemente alterato agli esami senza provocare dolore, mentre un tendine apparentemente normale può essere causa di sintomi intensi, sottolineando l’importanza dell’esperienza clinica nell’interpretazione dei risultati».
Come si cura la tendinopatia non-inserzionale dell'Achille
Il primo passo nella gestione della tendinopatia non-inserzionale dell’Achille è sempre un approccio conservativo. Nelle fasi iniziali, il riposo non significa immobilità totale, ma piuttosto una sospensione temporanea delle attività ad alto impatto, come corsa o salti, sostituite da esercizi a basso carico, ad esempio ciclismo, vogatore o allenamento su ellittica.
«Tra le strategie più supportate dalle evidenze scientifiche figurano gli esercizi eccentrici, movimenti controllati che allungano il tendine mentre il muscolo si contrae», descrive il professor Maffulli. «Praticati con regolarità per sei-dodici settimane, questi esercizi migliorano la forza e la resistenza del tendine, contribuendo a ridurre il dolore. Va però precisato che raramente il tendine “guarisce” completamente: l’obiettivo della fisioterapia è soprattutto alleviare i sintomi e ripristinare la funzionalità, più che normalizzare la struttura del tessuto».
Un valido supporto aggiuntivo è offerto dalla terapia ad onde d’urto, che ha dimostrato un buon effetto analgesico. Al contrario, lo stretching tradizionale si è rivelato poco efficace: nella migliore delle ipotesi non apporta benefici, nella peggiore può peggiorare il quadro clinico, sottolineando l’importanza di un programma terapeutico mirato e guidato da professionisti esperti.
Quando serve l’intervento chirurgico
La chirurgia diventa necessaria solo quando i trattamenti conservativi non hanno portato risultati, generalmente dopo tre-sei mesi di terapia correttamente eseguita. Le tecniche operatorie variano dal minimamente invasivo, eseguibile in anestesia locale, alle procedure tradizionali che richiedono incisioni più ampie e tempi di recupero più lunghi. In ogni caso, la pazienza è fondamentale: i tempi biologici di guarigione non possono essere accelerati senza rischiare complicazioni.
«Un intervento mini-invasivo richiede circa tre mesi per il recupero, mentre uno classico può necessitare fino a sei mesi», spiega l’esperto. «Tentare scorciatoie può compromettere anche un’operazione eseguita in maniera perfetta».
Prevenire la tendinopatia, invece, non è semplice. Paradossalmente, gli esercizi eccentrici che costituiscono la base del trattamento possono, se eseguiti in modo scorretto o eccessivo, favorire l’insorgenza della patologia in soggetti sani. La regola d’oro resta quindi quella di aumentare gradualmente i carichi di lavoro, mantenendo un buon equilibrio muscolare e una postura corretta.
Sul fronte della ricerca, grande interesse è rivolto ai trattamenti biologici, come il PRP (plasma ricco di piastrine) e le cellule staminali. Finora, gli studi indipendenti non hanno dimostrato benefici superiori del PRP rispetto al placebo. Più promettente è invece lo studio delle cellule staminali presenti nel tendine stesso, che in futuro potrebbe aprire nuove possibilità di rigenerazione del tessuto. «Nel frattempo, la sfida rimane ascoltare il corpo prima che il dolore diventi cronico», conclude il professor Maffulli. «Il tendine non dimentica gli eccessi: il modo migliore per prendersene cura è rispettarne i tempi, senza forzature, perché ogni passo di guarigione, come ogni passo della corsa, ha bisogno del suo ritmo naturale».
Fai la tua domanda ai nostri esperti