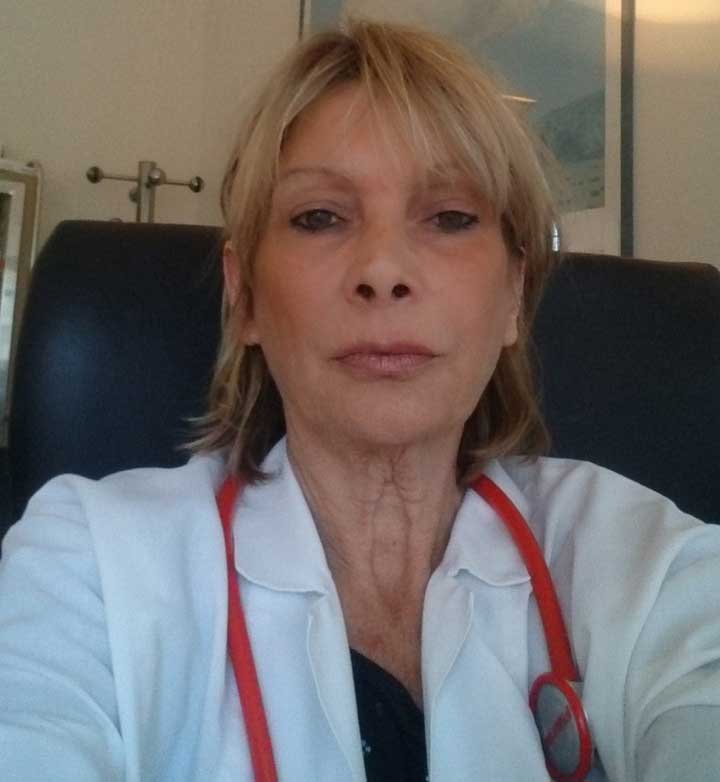Allora adesso con te non ci parlo più. Il silenzio punitivo lo hanno inventato i bambini. O meglio, lo hanno appreso dagli adulti e, nel loro perfetto mix di innocenza, immediatezza e scaltrezza, hanno capito che rende (un po’ come il pianto) e serve per ottenere qualcosa. Da grandi scopriranno che funziona ancora ma che, persa l’innocenza e la spontaneità, può diventare manipolatorio, cinico, persino cattivo. E fare male. In coppia, nei rapporti con gli altri, persino sul lavoro. Il silenzio punitivo viene usato da tanti e a qualsiasi età.
«In realtà abbiamo diversi tipi di silenzio, dove quello punitivo è la tipologia che si nota di più, perché immediatamente impattante sulla sfera emozionale», spiega la dottoressa Maria Giovanna Gatti Luini, medico senologo e psicoterapeuta.
Un campionario di personalità silenti
Gli individui che adottano il silenzio punitivo appartengono a diverse categorie di personalità, spiega l’esperta, e quindi usano il mutismo con motivazioni e modalità diverse.
«Il narcisista, per esempio, è un campione di taciturnità strumentale. Nelle dinamiche relazionali, infatti, si serve del silenzio come esercizio del suo potere sulle altre persone (spesso il partner). Meglio ancora: come punizione, come reazione a comportamenti che lui ritiene “ribelli” alle sue regole di vita, a ciò che ritiene giusto o meno, alternandoli a periodi di finta benevolenza, dove persino chiede scusa o fa finta che nulla sia successo: è la strategia del bastone e della carota, davvero frastornante per chi la subisce», spiega la dottoressa Gatti Luini.
«Per fortuna, numericamente, il vero narcisista “maligno o patologico”, il despota dei sentimenti, privo totalmente di empatia e con una voglia di prevaricare e di esercitare un potere sull’altro che è maniacale, non è molto diffuso. Nello stesso tempo, non si può affrontare e “migliorare” con le nostre sole forze, perché c’è bisogno di un esperto che, in questo caso, si occupi sia della vittima che del carnefice».
Qui, invece, ci dedichiamo ai casi di silenzio punitivo che sono lontani dalla “malattia”: di gran lunga più frequenti, assumono connotazioni meno violente e difficili da gestire.
Il passivo-aggressivo: ieri gentile, oggi silente
Il silenzio punitivo lo utilizza soprattutto chi ha una personalità passivo aggressiva: «Si tratta di persone che di solito appaiono agli altri come particolarmente riflessive e calme ma che, per vari motivi personali (legati al lavoro o alle relazioni, o che vengono da lontano, dall’infanzia e dai rapporti con i genitori) covano una rabbia nascosta, latente, che emerge di colpo anche nello scegliere di non parlare apposta per mettere in difficoltà gli altri.
In questi casi, il silenzio manipolatorio appare particolarmente spiazzante e quasi inspiegabile soprattutto perché chi lo adotta, in genere, è considerato una persona equilibrata e portata al dialogo. È improvviso, inaspettato, e coglie di sorpresa, insomma. E il rifiuto di spiegarsi, in chi lo adotta, lo rende ancora più doloroso per chi lo subisce, che non riconosce più la “persona che era prima” e non riesce a capire perché non ottiene le risposte che cerca. Soprattutto se il nuovo atteggiamento non si limita a poche ore o a un episodio isolato.
Quando, poi, succede in coppia il contraccolpo può essere rovinoso. «Fra partner, deve esistere una parità che è fondamentale, e pensare di “educare” l’altro con il silenzio è inaccettabile», afferma la dottoressa. «Certo, molto dipende da quanto dura il mutismo. Una cosa è un episodio ogni tanto, un’altra è sopportare un atteggiamento ripetuto o prolungato nel tempo. Qui, c’è un intento distruttivo della relazione, perché più dura il silenzio più fa danno, è efficace e quindi volontario, consapevole. E gli uomini sono più “bravi” delle donne a fare muro, ma non è detto che sia la fine di tutto. Se, prima o poi, si sente il bisogno di inframmezzarlo da parole che in teoria lo dovrebbero rafforzare, in realtà lo spezzano e, per fortuna, aprono a un nuovo dialogo», spiega l’esperta.
Sul lavoro: dal pettegolezzo al dividi e comanda
Il silenzio punitivo assume aspetti particolari nei rapporti di lavoro. «Se il personaggio passivo-aggressivo è il tuo capo, lo riconoscerai dal fatto che usa il silenzio con te mentre parla e dialoga con gli altri: divide et impera, dividi e comanda dicevano i latini, un atteggiamento che in una comunità può mandare nel panico, e non è certo sinonimo di buon comando», spiega la dottoressa Gatti Luini.
«Se invece è un collega con le stesse caratteristiche psicologiche ad adottare questa forma di manipolazione, aggiungerà spesso un altro accessorio spiacevole: il pettegolezzo. Il passivo aggressivo sul lavoro cerca alleati, li manda avanti per non compromettersi direttamente e, se lo affronti, non ammette mai colpe o comportamenti di questo tipo. Ma dobbiamo essere consci del fatto che non siamo noi ad avere difficoltà relazionali, e portarlo allo scoperto, se serve anche agli occhi degli altri.
Mai infatti subire un silenzio punitivo, e mai troppo a lungo: piuttosto confrontiamoci con un collega che stimiamo, più saggio ed equilibrato, con una figura istituzionale super partes ma anche con uno psicoterapeuta, per gestire la comunicazione col soggetto “silenzioso”, che agisca in modo consapevole o meno. Anche perché, come vedremo, il silenzio punitivo, per funzionare al massimo, deve durare nel tempo, e non tutti quelli che lo praticano sanno reggere il gioco, soprattutto se noi non subiamo passivamente».
Quando è sinonimo di insicurezza: non parlo per nascondermi
Non tutti i silenziatori, a volere specificare, hanno dietro la canna di una pistola che vuole ferire.
«Esiste, in effetti, anche il silenzio evitante», spiega Gatti Luini. «Evito di affrontare un argomento spinoso: soprattutto molti uomini lo fanno con la partner. Aspetto, sto zitto, tanto poi le passa. Ma non è sempre solo menefreghismo o furbiziascorciatoia per scavalcare noiose polemiche: è spesso anche frutto della paura di esprimere le proprie idee quando il clima, intorno, non è positivo e accogliente. Il problema dell’uomo evitante può essere l’insicurezza, anche perché in parte subisce anche lui il suo silenzio, non lo usa e basta per arrivare allo scopo. Dietro, ci può essere una difficoltà comunicativa: se sei una persona che fa fatica a parlare con gli altri in certe situazioni, a un certo punto scopri che quella tua caratteristica può essere dissimulata, con un silenzio di quel genere, e te ne servi. Bisogna tenerne conto, perciò, quando ci chiediamo perché sta zitto».
Dunque il silenzio evitante non vede sempre una persona consapevole dell’azione manipolatoria: «Lo si capisce dal momento in cui questi soggetti, prima o poi, ti vengono a cercare per parlare o “fare la pace”. Con gli evitanti l’aiuto terapeutico può coinvolgere la coppia in modo da ritrovare un dialogo comune e, contemporaneamente, sviscerare le insicurezze di chi sta tacendo troppo».
Cosa fare se lo subisci, ma anche per aiutare l’altro
«Quando subiamo per la prima volta un silenzio inaspettato possiamo attendere per reagire e non incalzare l’altro con domande sui motivi; ma, mi raccomando, non riempiamo quel vuoto con le nostre fantasie, perché il rischio è quello di elucubrare da soli dei problemi inesistenti, coinvolgendo magari le amiche o i vari confidenti, immaginando cosa stia accadendo nella testa di chi lo fa», raccomanda la psicoterapeuta.
«Il problema sta proprio nel fatto che invece spesso lo riempiamo, appunto, con le nostre paure e congetture. E per di più chiediamo agli amici che colmino quell’assenza di parole con le loro convinzioni e timori. Ma così il silenzio diventa un mondo parallelo a sé stante, spesso molto più grande, insidioso e doloroso del silenzio che stiamo subendo».
E se si ripete in più di un’occasione? «Quando c’è pace fra le parti, glielo si dice: guarda, io soffro, non farlo», sottolinea la psicoterapeuta.
«Se però, nonostante i nostri sforzi questo silenzio rimane ostinato, anzi si replica malgrado le promesse di non ripeterlo o, peggio, viene negato e diventa così davvero insopportabile, occorre mettere la persona di fronte a un aut-aut: o ti fai aiutare, e quindi esci da questa modalità tossica per tutti e due, oppure calerà il silenzio anche per me e poi me ne andrò, scapperò fisicamente da questa situazione, più prima che poi».
Quel vuoto di parole che fa da specchio
Dunque, se il rapporto conta qualcosa e l’altro è assertivo nel suo rifiuto al silenzio, anche il passivo-aggressivo e, a maggior ragione l’evitante, dovrebbero almeno provare a chiedere/accettare aiuto, consiglio, provare la psicoterapia. E lì cosa succede?
«Paradossalmente, anche in terapia, il silenzio viene usato come tecnica quando il paziente non riesce a vedere qualcosa di sé ma cerca una soluzione», conclude la nostra esperta.
«Allora, mentre parla e fa domande anche aggressive (frequenti nei soggetti passivo aggressivi) a un certo punto il terapeuta non risponde e, semplicemente, guarda. Quando hai agganciato il paziente e riesci a mantenere il silenzio in quello sguardo, a un certo punto succede che in una reazione a specchio l’altro si rende conto di cosa ha detto, di cosa sta facendo e vede anche delle possibili soluzioni. Cioè realizza che quello è il problema, e che potrebbe esserci una via d’uscita. Vede finalmente la realtà del suo comportamento, vede se stesso specchiandosi nel silenzio. È un tacere che può essere assoluto, oppure un momento in cui il terapeuta ripete semplicemente l'ultima frase che la persona ha detto, cioè gliela ripropone senza commenti, e poi tace. E questo può essere molto toccante e positivo, in terapia».
- LEGGI ANCHE: Silenzio punitivo, differenze tra uomo e donna
- LEGGI ANCHE: Silenzio verso i figli: quando è educativo
Fai la tua domanda ai nostri esperti