Corpi chetonici nelle urine: cosa sono, cause, rischi
L’organismo produce corpi chetonici quando il glucosio scarseggia, trasformando i grassi in energia. La loro presenza nelle urine o nel sangue può essere fisiologica, come durante digiuni o diete a basso contenuto di carboidrati, oppure indicare situazioni di rischio che richiedono attenzione medica
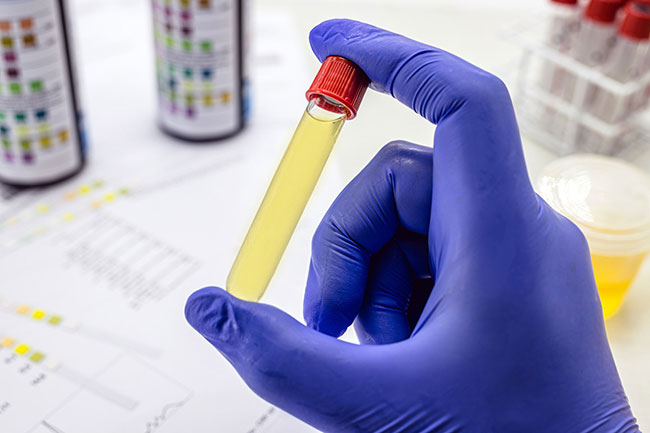
Il nostro corpo somiglia a una macchina ibrida: normalmente utilizza il glucosio come carburante principale, ma se questo scarseggia si affida a una fonte alternativa. È allora che entrano in gioco i corpi chetonici, piccole molecole che possono diventare preziose alleate energetiche o segnali di allarme, a seconda della situazione. La loro presenza nelle urine corrisponde a un messaggio inviato dal metabolismo: può rivelare che stiamo bruciando i grassi in modo naturale oppure indicare che qualcosa nel nostro equilibrio interno non funziona correttamente.
Cosa sono i corpi chetonici
I corpi chetonici sono sostanze prodotte dal fegato quando l’organismo non dispone di zuccheri sufficienti e ha bisogno di energia. In altre parole, quando il “serbatoio” di glucosio si esaurisce, il corpo inizia a bruciare i grassi, trasformandoli in questi piccoli composti energetici.
«Può sembrare un fenomeno positivo», spiega la dottoressa Serena Castronovo, dietista e nutrizionista ad Agrigento. «Ed effettivamente lo è, almeno in alcuni casi: la famosa dieta chetogenica si basa proprio su questo meccanismo, sfruttando la produzione di corpi chetonici per stimolare il consumo dei grassi».
Tuttavia la loro presenza non è sempre innocua. Analizzarne la concentrazione nelle urine aiuta a capire se ci troviamo in una condizione fisiologica o se è necessario prestare attenzione. Valori modesti, fino a circa 20 mg/dL, possono essere considerati normali e comparire, ad esempio, dopo un breve digiuno, un’intensa attività fisica o una dieta povera di carboidrati.
Quando la concentrazione si colloca tra 20 e 40 mg/dL, è opportuno monitorare la situazione: potrebbe indicare un leggero deficit di carboidrati o una lieve disidratazione, ma resta comunque entro limiti generalmente sicuri. «Valori superiori ai 40 mg/dL, invece, possono segnalare condizioni più serie, come diabete, malnutrizione, infezioni o problemi epatici, situazioni che richiedono una valutazione medica accurata», indica l’esperta.
Come si misurano i corpi chetonici
I corpi chetonici vengono rilevati principalmente nelle urine, il principale mezzo attraverso cui l’organismo li elimina. L’analisi è semplice, rapida e permette di individuare sia tracce minime sia concentrazioni elevate, offrendo un primo indicatore dello stato metabolico.
«Il dosaggio nel sangue, invece, viene riservato a situazioni particolari o a sospetti di condizioni più gravi, come la chetoacidosi diabetica», specifica la dottoressa Castronovo. Questo metodo è più accurato, perché permette di quantificare i chetoni attivi presenti in circolo, ma non viene impiegato di routine: è più invasivo e costoso rispetto all’analisi urinaria.
Quali sono i rischi
La presenza di corpi chetonici non è sempre motivo di preoccupazione. In molte situazioni naturali, come un breve digiuno, un’intensa attività fisica o diete a basso contenuto di carboidrati, la loro comparsa è del tutto fisiologica. In questi casi, la maggior parte delle persone non avverte sintomi particolari; talvolta si percepisce solo un alito leggermente fruttato o un aumento della sete, mentre l’energia può risultare più stabile grazie all’uso dei grassi come carburante.
«Le cose cambiano quando si supera una certa soglia e si entra nella chetoacidosi, una condizione seria in cui l’accumulo eccessivo di corpi chetonici altera il pH del sangue, provocando uno squilibrio metabolico», spiega la dottoressa Castronovo. «Può verificarsi nei bambini durante febbri o episodi di vomito prolungato, in persone con diabete di tipo 1 non controllato, in casi gravi di diabete di tipo 2 oppure in seguito ad abuso di alcol o digiuni estremi. Nei più piccoli, l’odore di acetone nell’alito può essere un segnale di chetosi transitoria, generalmente innocua, ma se associato a malessere, vomito o letargia richiede un’attenzione medica immediata».
In sostanza, la distinzione è cruciale: la chetosi è una risposta fisiologica naturale del metabolismo, mentre la chetoacidosi rappresenta una situazione patologica che richiede intervento tempestivo.
Che cosa fare
Quando i valori di corpi chetonici superano i 40 mg/dL, è necessario prestare attenzione immediata. Un singolo riscontro non consente di fare una diagnosi definitiva, ma richiede di ripetere l’esame a breve distanza e di valutare l’insieme dei dati clinici insieme al medico.
«L’alimentazione gioca un ruolo fondamentale», assicura la dottoressa Castronovo. «Chi segue una dieta chetogenica sa che la comparsa di corpi chetonici è prevista e generalmente monitorata. Tuttavia, mantenere uno stato di chetosi estrema per più di tre settimane è raro, perché anche alimenti a basso contenuto di carboidrati, come verdure e frutta, forniscono zuccheri sufficienti a impedire livelli pericolosi».
Diversa è la situazione per chi non segue una dieta chetogenica e riscontra corpi chetonici nelle urine. Valori elevati in questi casi possono rappresentare un rischio per l’organismo. «La chetoacidosi può manifestarsi con sintomi come confusione, nausea, vomito, alito fruttato, sete intensa e stanchezza», elenca l’esperta. «In questa condizione, il sangue diventa acido e l’equilibrio metabolico rischia di compromettersi seriamente, rendendo indispensabile un intervento medico tempestivo».
Il legame con il colesterolo
Molti pensano che la scomposizione dei grassi, tipica della chetosi, porti automaticamente a un calo del colesterolo, ma la realtà è più complessa. Durante una dieta chetogenica si possono osservare variazioni nei livelli di colesterolo, ma questi effetti dipendono da numerosi fattori, tra cui la genetica e la composizione complessiva dell’alimentazione. Limitare i grassi saturi e mantenere un’alimentazione equilibrata resta il modo più efficace per tenere sotto controllo il colesterolo, senza ricorrere a regimi estremi.
Anche se la chetosi comporta la trasformazione dei grassi in energia, non garantisce automaticamente una riduzione del colesterolo totale o di quello “cattivo” (LDL); in alcuni casi può addirittura ridurre il colesterolo “buono” (HDL). Per questo motivo, considerare la dieta chetogenica come un rimedio miracoloso per abbassare il colesterolo è un errore: i risultati variano da persona a persona e, in presenza di condizioni ereditarie come l’ipercolesterolemia familiare, la sola chetosi non è sufficiente.
Fai la tua domanda ai nostri esperti










