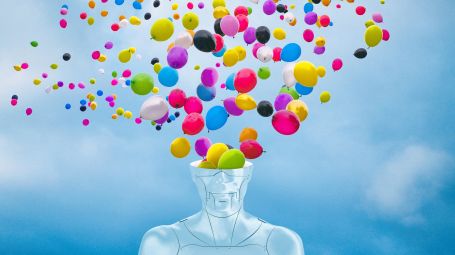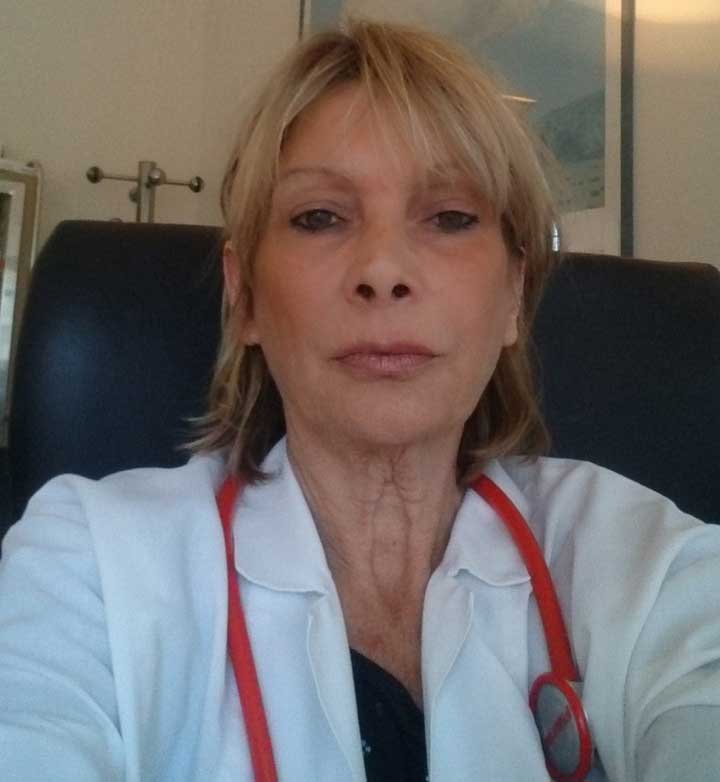Oggi sul banco degli imputati abbiamo il digitale, in particolare la sua declinazione ritenuta più pericolosa, soprattutto per i giovani: lo smartphone. Disattenzione, ansia, solitudine sono solo alcuni dei sintomi con cui si tende a diagnosticare la morbosa dipendenza dalla tecnologia più temuta e più utilizzata. Contro di lei, c’è chi rimpiange i bei tempi che non conoscevano connessioni e chi rincorre formule di moderazione o interdizione. Il saggio Oltre la tecnofobia (Raffaele Cortina, 16 €) propone un’opzione diversa, che crea una mappa approfondita per abitare e interpretare consapevolmente l’ecosistema digitale in cui siamo immersi e che continuerà a crescere.
Starbene ha intervistato Stefano Moriggi, filosofo e autore del libro insieme a Vittorio Gallese, neuroscienziato, e Pier Cesare Rivoltella, pedagogista.
Perché abbiamo il dito puntato contro le nuove tecnologie?
«È una reazione consueta. Ogni volta che si è manifestata sulla scena della storia un’innovazione in grado di cambiare radicalmente le abitudini pratiche e cognitive delle persone, da un lato ha acceso gli entusiasmi di alcuni, dall’altro ha sollevato, in maniera diffusa e sistematica, le perplessità, per non dire le angosce, di molti».
Da cosa dipende questa reazione “drammatica”?
«Da un meccanismo insito da sempre nella specie umana. Più in dettaglio, il cervello ha imparato a riconoscere, nella molteplicità del mondo, delle regolarità (i cosiddetti pattern) che derivano dall’esperienza passata e che ci hanno permesso di provare a fare previsioni sul futuro, dunque a sviluppare strategie di difesa, di attacco, di conoscenza, consentendo all’umanità di arrivare fin qui.
Ma questa competenza ha anche un’altra faccia: quando, al posto della regolarità, si palesa una novità potente scivoliamo nella paura. Nasce perché proviamo a interpretare, classificare e gestire il nuovo con le stesse categorie di pensiero con cui abbiamo “amministrato” la tradizione, perciò non ci stiamo più dentro. Freud definiva queste transizioni con l’espressione “non sentirsi a casa”, essere smarriti».
Siamo spaventati dalle nostre stesse creazioni?
«Sì, è andata così con la scrittura alfabetica, l’industrializzazione, la fotografia, il cinema, la televisione e anche Internet. Senza eccezioni, ogni rivoluzione tecno-scientifica si è portata dietro il gap tra il creatore e l’invenzione che finisce per dominarlo. Dietro a questa paura c’è l’idea di perdere qualcosa che reputiamo prerogativa dell’essere umano delegandolo completamente alla “macchina”.
Ma adesso la tecnologia, nel dibattito pubblico, è sottoposta a una forma di contestazione più subdola, strisciante: è utile, bisogna usarla ma non abusarne e, in alcuni casi, vietarla. Il freno è rivolto soprattutto alle giovani generazioni, le più colpite dall’ondata di tecnofobia: bisogna interdire gli strumenti digitali fino a una certa età e favorirne un uso controllato, a scuola e in famiglia. Ma il buonsenso non funziona bene in questa specifica situazione».
È sbagliato questo invito prudenziale?
«Il buonsenso, con tutte le sue declinazioni pratiche di limiti, controlli e divieti, da un certo punto di vista è la stratificazione di competenze e conoscenze che si sono consolidate in un contesto culturale completamente diverso da quello odierno. Manca un tassello fondamentale: visto che la tecnologia ci fa agire e pensare in un altro modo, come possiamo pensare di governare il nuovo con il vecchio?».
Tipo?
«Gli esempi tecnofobici sono innumerevoli. Uno per tutti, che lo smartphone danneggi l’attività cognitiva dei giovanissimi. Qualcuno sostiene, addirittura, che stimolerebbe connessioni neurali sbagliate. Peccato che la neuroscienza dica che il nostro cervello è strutturalmente plastico e, perciò, si modifica ogni qualvolta interagisca con una certa persona o un certo oggetto.
Di insensatezza in insensatezza, quindi, si sta togliendo ai ragazzi la possibilità di imparare, a scuola e in famiglia, a utilizzare le nuove tecnologie, che, volenti o nolenti, dovranno sempre più adoperare da adulti, nella loro vita professionale e privata. Pertanto, con la tecnofobia imperante si consegna loro un disagio che li espone, questa volta volta sì, a degli usi potenzialmente impropri».
Divieti e controlli non funzionano bene, perciò...
«Una premessa: dalle origini in poi, noi non pensiamo e agiamo indipendentemente dalle tecnologie con cui ci interfacciamo. Di conseguenza, che senso ha mettere lo smartphone sotto chiave? Impedisce solo ai più giovani di riscrivere il modo giusto di stare in un mondo sempre più pervaso da strumenti digitali.
Viceversa, bisognerebbe capire che cos’è quella macchina, scoprire i suoi molteplici impieghi e che tipo di interazioni consente, che ricadute potrebbe avere sulle nostre pratiche quotidiane e come fare per arricchirle. In questa esplorazione a tutto tondo serve più ricerca scientifica (pedagogica, epistemologica, neurologica) sicuramente, ma anche un atteggiamento diverso di noi adulti, genitori e insegnanti in testa».
Ossia?
«È indispensabile lavorare a favore di una cittadinanza digitale matura, intesa come strumento positivo di emancipazione del genere umano e lontana da ogni forma di tecnofobia. Per arrivarci, bisogna aiutare i bambini, anche dalla più tenera età, a padroneggiare questi nuovi dispostivi. Solo la formazione fa crescere gradualmente la capacità dei giovanissimi di interfacciarsi criticamente con gli strumenti digitali e favorire la loro capacità di autoregolazione. Educare, infatti, non consiste nel proibire ma nel consentire di fare, agire e sperimentare: il lasciare andare è essenziale, dal momento che permette ai neofiti di imparare in autonomia e responsabilmente».
Qualche ricetta della quotidianità?
«Non si tratta di acquisire competenze informatiche, e neanche di “abbandonare” i ragazzi davanti a uno smartphone. Prioritaria e proficua, invece, è la condivisione. Come avere dei momenti in cui genitori e bambini usano insieme il cellulare, per progettare una gita domenicale o una vacanza in famiglia e trovare in Rete le informazioni necessarie a capire dove andare, come arrivarci, quanto tempo ci vuole, cosa vedere e fare.
Creare insieme questi percorsi serve a sperimentare le potenzialità multialfabetiche del cellulare e costruire un piccolo compito di realtà. Ma anche una ricerca scolastica potrebbe essere integrata da articoli, immagini, video trovati in Rete. L’educazione digitale sta in un concetto semplice: no a un uso povero della tecnologia – faccio la domanda su Internet e la macchina mi restituisce subito le informazioni richieste – ma più ricco e aggiornato rispetto agli strumenti tradizionali».
Ci sono altre ricadute positive?
«Se io penso di controllare mio figlio con un parent control, non tengo conto del fatto che troverà sempre il modo di aggirarmi. Se, invece, instauro un’attività cooperativa dettata da un fine in comune, tipo una bella gita, lui sarà motivato e interessato a farmi sapere cosa sa fare in Rete, magari meglio di me. Così io adulto lo conosco meglio (perché capisco come il ragazzo usa il mezzo) e, soprattutto, metto le basi di una relazione di fiducia e collaborazione reciproca. Che non esclude una percentuale di rischio, ma abitua a parlarne insieme. Questo è un obiettivo importante, trovare una complicità di prassi, di condivisione, di partecipazione anche legate a cose concrete».
E il problema “tanto smartphone e poche relazioni sociali”?
«È opinione diffusa che i ragazzi stiano più sui social che nella vita reale. Eppure, se andiamo a vedere le ricerche, di solito le persone che hanno delle frequentazioni più strutturate su Instagram o altro sono anche quelle che possiedono una vita relazionale più sviluppata. In più, è stato smontato anche il caso, estremo, degli hikikomori. Quegli adolescenti che si trincerano nella loro camera e hanno contatti solo nel virtuale, non sono il risultato dell’abuso di tecnologie, ma di una pressione sociale e familiare ingestibile. Per loro, l’uso smodato di Internet, è l’unica via possibile per vivere. Tutto questo per dire che, con troppa facilità e superficialità, si addossa alle nuove tecnologie la crisi della scuola, della famiglia, della socialità, senza prendersi la responsabilità di indagarle per quello che veramente sono».
Come possiamo ratificare?
«Per me, riscoprendo la lezione del filosofo Gilbert Simondon: la tecnologia non può essere ridotta al solo scopo utilitaristico (serve per…) ma produce sempre nuovi rapporti tra le persone, tra le cose e tra le persone e le cose, quindi è una rete di relazioni. Come dire, è la pelle dell’umano e chiede di porre al centro un Uomo rinnovato. Che non si difende dallo smartphone o ne è subordinato ma conosce a fondo il mezzo, i meccanismi, le potenzialità e i rischi, e trasmette queste informazioni alle giovani generazioni».
Fai la tua domanda ai nostri esperti