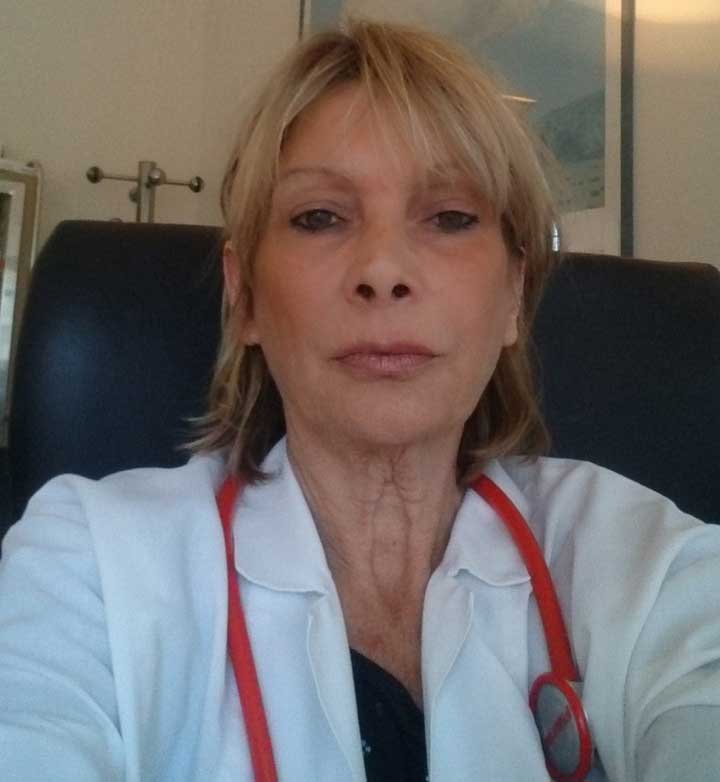La respiriamo tutti i giorni, la gerarchia. Però a occhi chiusi, senza conoscerla. Semmai, ne accusiamo i contraccolpi, come una zavorra continua di ansia, stress, demotivazione, paura in ufficio come fuori, che ci pesa tantissimo sulle spalle, che ci fa saltare anche i nervi ma che accettiamo come un “obbligo” ineluttabile. Eppure, la gerarchia è un concetto da esplorare, neanche tanto astratto, perché sapere che i suoi limiti sono imposti dalla tradizione mentre i tuoi meriti aspettano solo di essere potenziati, potrebbe trasformarla in una risorsa fondamentale per la qualità del lavoro, e per la qualità di vita in generale.
«Sono state scritte tonnellate di saggi sulla leadership, ma non parliamo mai di gerarchia», dice Marina Capizzi, autrice di Non morire di gerarchia (Franco Angeli, 27 €), il primo libro in Italia sull’argomento. «Mentre la prima si occupa di comportamenti, la seconda struttura la distribuzione del potere decisionale all’interno dei sistemi sociali. Quindi, è la gerarchia che crea il reale campo da gioco nel quale operiamo».
Dottoressa Capizzi, qual è il problema?
«Ancora oggi non siamo così consapevoli degli effetti che la gerarchia organizzativa tradizionale crea nei nostri contesti di lavoro e via dicendo, perché siamo vittime della paura che mettendo in discussione questa logistica si piombi nel caos o in una specie di “reato di lesa maestà”. Ora, questi timori vanno superati dal momento che sappiamo molto bene cosa mettere in campo per l’evoluzione della gerarchia organizzativa».
Oggi per gerarchia cosa intendiamo?
«Per noi, la gerarchia coincide con la piramide, il sistema di potere all’interno dei gruppi sociali. Da sempre, le nostre istituzioni (stato, chiesa, scuola ecc.), le imprese, le organizzazioni no profit, le associazioni, i partiti sono strutturati allo stesso modo: chi sta in alto pensa e decide, chi sta in basso esegue e realizza».
Questo ordine funziona ancora?
«La gerarchia che concentra il potere decisionale solo in alto poteva essere efficiente anni fa, in un mondo più semplice e che permetteva delle programmazioni a lungo termine. Ormai, tutto questo è inadeguato per i nostri tempi, così veloci e variabili. Pensiamo al lavoro come esempio macroscopico: la gerarchia tradizionale propone modelli di comportamento che sono fonte di continui disagi e costi per tutti, anche per gli stessi capi. E quando dico costi intendo lentezza, frustrazione, ansia, demotivazione, deresponsabilizzazione, eccesso di burocrazia, conflittualità tossica tra uffici e funzioni, eccessiva attenzione allo status, focalizzazione sui compiti da svolgere e non sui risultati da costruire insieme.
La gerarchia che ci arriva dal passato crea un sacco di steccati e di confini, e rende il lavoro più faticoso e in sottrazione di soddisfazioni da qualsiasi punto di vista. Sia personale (è come se tantissimi individui fossero pagati per “non pensare”) sia produttivo (la struttura s’ingessa poiché il vertice non riesce a dare risposte adeguate e tempestive a chi in basso si relaziona con clienti/utenti)».
Cambiare significa eliminare?
«No, sarebbe il caos. La gerarchia è una risorsa che crea un ordine di importanza, necessario per governare le situazioni che viviamo. Noi esseri umani “fabbrichiamo” continuamente graduatorie individuali e collettive: degli affetti (le persone a cui vogliamo più bene), dei valori (gli ideali più importanti per noi), delle priorità (l’importanza e l’urgenza delle cose da fare), delle attività e/o situazioni che ci fanno stare bene e di quelle che ci fanno stare male.
Quando progettiamo una vacanza, per esempio, ci diamo una scaletta di precedenze, perché ci chiediamo: “Cos’è più importante per noi: riposarci, divertirci o vedere posti nuovi?”. La gerarchia, in breve, è dentro e fuori di noi. Quella biologica ci fa agire in un certo modo, quella culturale ci dice cosa fare o non fare nel contesto in cui siamo nati e viviamo».
Come si inizia a sfruttare questa risorsa?
«Diventando consapevoli delle gerarchie in cui viviamo. Troppo spesso agiamo in automatico e non ci rendiamo conto che siamo dominati dalle graduatorie di ruolo, anche in modo inconsapevole. Un caso tipico? In riunione non parliamo, prigionieri dell’abitudine che lo fa solo il capo.
Magari ci lamentiamo che siamo invisibili, che non contiamo niente, che non abbiamo occasioni di chiarire criticità o proporre iniziative ma poi è la strizza di uscire dalla nostra comfort zone che ci mette al riparo da un’esposizione compromettente, e ci silenzia. Invece, bisognerebbe sempre ragionare sulle gerarchie da eliminare (e perché), su quelle da trasformare, su quelle da creare ex novo. È un lavoro dinamico che ha bisogno del contributo di tutti, dall’alto in basso, per rifondare la cultura gerarchica tradizionale».
Da dove si comincia?
«Dalla nostra biologia, suggerisce Stephen Porges, il maggior studioso del sistema nervoso autonomo. Qui, si nasconde un ordinamento gerarchico fatto da tre livelli, tutti legati alla ricerca della nostra sicurezza: il primo ci protegge attraverso l’isolamento, il secondo con la difesa/attacco, il terzo ci mette in connessione. Quest’ultimo andrebbe attivato più spesso possibile: ci porta a tutelarci mettendoci in collegamento (e non in conflitto) con gli altri. Per arrivare a obiettivi comuni, verso un modello evolutivo di gerarchia».
Ci dà qualche raffigurazione?
«Quando ci difendiamo nella modalità fuga ci sottraiamo alle responsabilità, non rispondiamo, non ci facciamo trovare, non diciamo quello che pensiamo, nicchiamo. Mentre se siamo nella piattaforma neurale difesa/attacco, smettiamo di ascoltare, alziamo il tono di voce, interrompiamo in continuazione, sentiamo una fortissima esigenza di affermarci, di avere ragione, cerchiamo la causa di tutte le criticità negli altri, vediamo solo i loro aspetti negativi, alimentiamo azioni di guerra… Entrambe le modalità nutrono conflitti, disegnano confini (“io” contro “l’altro”, “noi” contro di “loro”), spingono all’auto-centratura, alla frantumazione, ci portano a perdere di vista l’insieme e mettono in circolo energia negativa».
E quando siamo nel livello più evoluto?
«Sorridiamo, ci avviciniamo, ci parliamo, ci ascoltiamo, cambiamo idea, chiediamo aiuto e aiutiamo, mettiamo insieme le nostre conoscenze, capacità e competenze per risolvere un problema e imparare a fare meglio per tutti, ci mettiamo in discussione, siamo disponibili a sperimentare strade nuove. Possiamo accelerare le nostre azioni ma anche frenare, riflettere. Possiamo litigare, dirci le cose a muso duro, combattere affinché si realizzi ciò che riteniamo utile, ma senza dare la caccia al colpevole se le cose non vanno bene.
La connessione regola le nostre energie e ci consente di essere presenti, flessibili, capaci di adattarci alle situazioni nuove e di integrare aspetti che, quando siamo negli altri stati, percepiamo come opposti: sopravvivenza e connessione, paura e coraggio, difesa e collaborazione, attenzione focalizzata e percezione ampia, dettaglio e visione d’insieme, punti di forza e punti deboli, presente e futuro, libertà e vincoli, minacce e opportunità, caratteristiche nostre e degli altri».
Tutto a nostro favore, quindi…
«Come dice la clinica Deb Dana, siamo affamati di connessione perché solo quando siamo interconnessi abbiamo le uniche condizioni per stare bene e favorire la salute psicofisica. Non siamo noi, comunque, a decidere quale livello neuronale attivare in una data situazione. Però, se conosciamo il nostro sistema nervoso autonomo possiamo imparare a riconoscere in quale stato gerarchico ci troviamo e agire di conseguenza, per alimentare lo stato di connessione o ristabilirlo se lo abbiamo perso».
Si può rimanere schiacciati nel gruppo?
«Macché, la gerarchia biologica di connessione non ci snatura, anzi ci porta a essere la migliore versione di noi stessi, accediamo alle nostre risorse più pregiate e possiamo affrontare insieme sfide e minacce, con meno fatica e con maggiori possibilità di riuscirci. L’impegno di noi studiosi dei sistemi organizzativiproduttivi è coltivare nelle imprese la gerarchia biologica più evoluta. Già la possediamo, dobbiamo imparare a conoscerla e partire da qui per creare le altre gerarchie che ci permettono di lavorare e vivere sempre meglio».
Fai la tua domanda ai nostri esperti