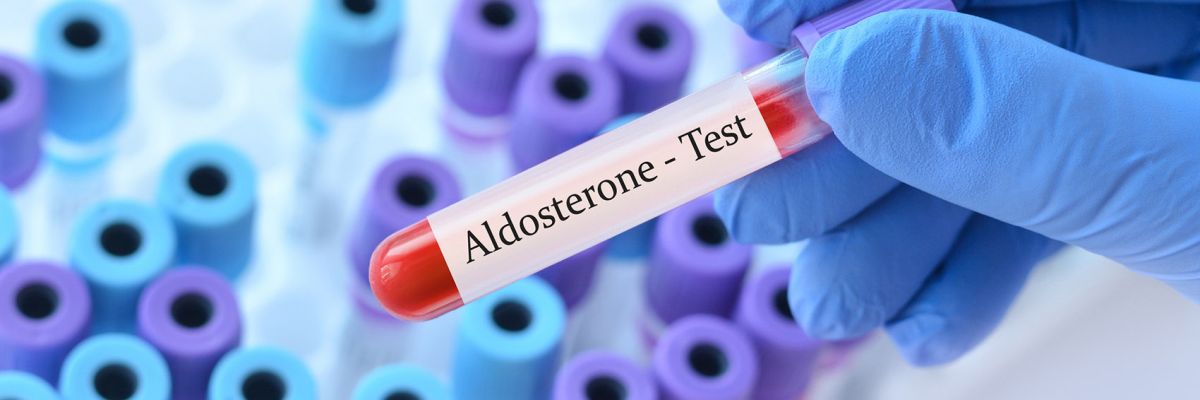L’iperaldosteronismo è una condizione caratterizzata da un’eccessiva produzione di aldosterone, un ormone fondamentale che viene prodotto dalle ghiandole surrenali. Queste piccole ma vitali strutture, situate sopra i reni, sono responsabili della sintesi di alcuni ormoni essenziali, come il cortisolo e le catecolamine, che regolano numerose funzioni fisiologiche e intervengono in molte condizioni patologiche e di emergenza. Fra questi, l’aldosterone svolge un ruolo centrale nel controllo dell’equilibrio idro-salino, modulando gli scambi di sodio e potassio e influenzando la quantità di liquidi presenti nell’organismo.
Cos’è l’iperaldosteronismo
Quando la produzione di aldosterone diventa eccessiva, si crea una condizione di ritenzione idrica che determina un aumento della pressione arteriosa.
«Questa forma di ipertensione rientra nella categoria delle ipertensioni secondarie, distinguendosi dalla più comune ipertensione essenziale, responsabile del 90% circa dei casi, che non ha una causa precisa e spesso è il risultato di fattori genetici e ambientali», spiega il dottor Carlo Artioli, endocrinologo del Centro Medico Lazzaro Spallanzani di Reggio Emilia.
«Nell’iperaldosteronismo, invece, la pressione alta ha un’origine chiara e, soprattutto, trattabile: identificare precocemente questa condizione può non solo migliorare significativamente la pressione arteriosa, ma in molti casi portare a una vera e propria remissione dell’ipertensione».
Quali sono i sintomi dell'iperaldosteronismo
Il quadro clinico dell’iperaldosteronismo può manifestarsi inizialmente in modo subdolo, con sintomi spesso sfumati e di difficile riconoscimento. «Il segnale principale è l’ipertensione arteriosa, conseguenza diretta della ritenzione di sodio e acqua, indotta dall’eccesso di aldosterone», descrive il dottor Artioli. «Tuttavia, la condizione comporta anche una perdita progressiva di potassio, che può tradursi in debolezza muscolare, crampi frequenti e, nei casi più gravi, aritmie cardiache». Questo insieme di alterazioni elettrolitiche e pressorie crea un quadro complesso, spesso sottovalutato, perché molti pazienti non percepiscono disturbi evidenti nelle fasi iniziali.
Oltre ai sintomi legati alla pressione alta, come mal di testa e capogiri, è proprio la combinazione con la carenza di potassio a rendere l’iperaldosteronismo clinicamente significativo.
«La rilevanza di una diagnosi tempestiva va oltre il semplice controllo della pressione, perché l’eccesso di aldosterone può provocare danni diretti al sistema vascolare e al cuore, compromettendo la funzionalità arteriosa», avverte l’esperto. «Se la condizione viene riconosciuta tardivamente, questi danni possono stabilizzarsi in modo permanente, limitando la possibilità di una completa remissione dell’ipertensione anche dopo il trattamento».
Quali sono le cause dell'eccesso di aldosterone
Quando è causato da una produzione autonoma delle ghiandole surrenali, l’iperaldosteronismo viene definito “primario” e può manifestarsi principalmente per due motivi differenti, che riflettono la complessità del controllo ormonale sulle ghiandole surrenali. «Una delle cause più note è l’adenoma surrenalico, un piccolo tumore benigno che si sviluppa in una delle ghiandole e che produce aldosterone in eccesso», indica il dottor Artioli. «Sebbene di natura benigna, questo adenoma altera profondamente l’equilibrio elettrolitico e pressorio, determinando gli effetti clinici tipici della condizione».
Più frequentemente, tuttavia, l’iperaldosteronismo primario è legato a una condizione nota come iperplasia surrenalica bilaterale, dove entrambe le ghiandole iniziano a secernere quantità elevate di aldosterone senza che sia possibile individuare una causa precisa. «Si ritiene che fattori genetici possano influenzare questo meccanismo, ma per ora le conoscenze disponibili non consentono di prevedere né prevenire lo sviluppo della malattia», ammette l’esperto.
Come si arriva alla diagnosi
La diagnosi richiede un’attenta osservazione clinica e una valutazione mirata dei parametri ormonali. Non basta affidarsi unicamente ai valori del potassio, che in certi casi può essere addirittura normale: il sospetto deve sorgere soprattutto quando ci si trova di fronte a un paziente relativamente giovane con ipertensione o quando la pressione risulta sorprendentemente elevata rispetto a quanto osservato di norma nelle forme essenziali della malattia. «In questi casi, il primo passo consiste nel misurare il livello di aldosterone nel sangue e confrontarlo con quello della renina, un enzima proteico che stimola la produzione dell’ormone», suggerisce il dottor Artioli.
Il rapporto tra aldosterone e renina costituisce un indicatore chiave: valori superiori a 20-25 rafforzano il sospetto di iperaldosteronismo primario, indicando un’eccessiva secrezione ormonale di origine surrenalica. «A questo punto si procede a una diagnosi più diretta, attraverso imaging delle ghiandole surrenali», riprende l’esperto. «Una semplice tomografia assiale computerizzata, anche senza mezzo di contrasto, può individuare un adenoma in una delle ghiandole oppure confermare la presenza di iperplasia bilaterale, consentendo di stabilire con precisione la natura del disturbo».
Questo approccio diagnostico consente di distinguere le varie forme della patologia e di pianificare il trattamento più appropriato, fondamentale per limitare i danni a lungo termine provocati dall’eccesso di aldosterone.
Come si cura l'iperaldosteronismo
Una volta confermata la diagnosi di iperaldosteronismo, le strategie terapeutiche dipendono dalla natura specifica della patologia. «Nel caso dell’adenoma surrenalico, il trattamento definitivo consiste nell’asportazione chirurgica della ghiandola colpita», spiega il dottor Artioli. «L’intervento oggi si esegue in laparoscopia, una tecnica minimamente invasiva che riduce complicazioni e tempi di recupero, permettendo di eliminare la fonte dell’eccesso di aldosterone in modo preciso ed efficace».
Diversamente, quando si riscontra un’iperplasia bilaterale delle ghiandole surrenali, non è possibile rimuovere entrambe le ghiandole senza conseguenze gravi per l’organismo e, pertanto, il trattamento si basa sull’uso di diuretici anti-aldosteronici. «Questi farmaci, occupando i recettori dell’aldosterone, ne antagonizzano gli effetti, contrastando la ritenzione di liquidi e la perdita di potassio», chiarisce l’esperto.
Tra i più utilizzati c’è lo spironolattone, un farmaco tradizionale che, oltre a bloccare l’azione dell’aldosterone, contribuisce a risparmiare il potassio, fondamentale per prevenire debolezza muscolare e crampi tipici della carenza di questo minerale. «Una seconda opzione è rappresentata dall’eplerenone, un diuretico più moderno e selettivo che riduce gli effetti collaterali, in particolare quelli legati alla modulazione degli androgeni negli uomini, come variazioni della sessualità o calo della libido», illustra l’endocrinologo. La scelta del farmaco, così come il dosaggio, deve essere personalizzata in base al paziente, considerando la sua età e le caratteristiche individuali della malattia.
L'importanza della diagnosi precoce
«L’importante è arrivare a una diagnosi precoce», tiene a precisare il dottor Artioli. «Spesso, di fronte a un paziente con ipertensione, la tentazione del medico è quella di iniziare immediatamente la terapia farmacologica. Sebbene i farmaci antipertensivi possano ridurre la pressione, se l’iperaldosteronismo non viene riconosciuto, la condizione sottostante continua a danneggiare il sistema cardiovascolare e, nel tempo, può rendere necessaria una terapia più complessa con più principi attivi».
Per questo motivo, i dosaggi di aldosterone e renina dovrebbero essere effettuati prima di iniziare qualsiasi trattamento farmacologico, evitando falsi positivi o negativi che possano compromettere la valutazione. «Nei pazienti già in terapia, la sospensione dei farmaci per alcune settimane può essere necessaria per ottenere misurazioni accurate, ma si tratta di una procedura complessa, che richiede monitoraggio e attenzione», conclude l’esperto.
Fai la tua domanda ai nostri esperti