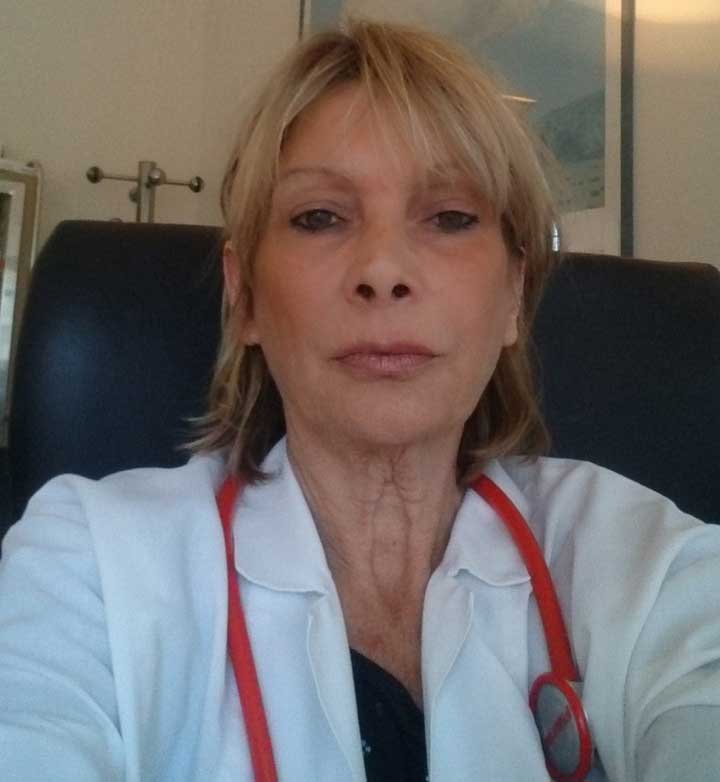Quando nella vita si aprono le porte, e succede infinite volte, possiamo oltrepassarle, rimanere sulla soglia o tornare improvvisamente indietro. Poco importa, senza speranza non si potrebbe mai intravedere quello spiraglio di luce (anche se in siffati anni ne vediamo pochi di bagliori all’orizzonte). Ci dice Emiliana Mangone, sociologa che insieme al collega Guido Gili ha scritto un saggio sull’argomento (Speranza, passione del possibile, Vita e Pensiero, 20 €).
«Storicamente ci sono dei tempi in cui la speranza è maggiormente coltivata, altri meno come succede ora. I primi decenni di questo millennio hanno visto succedersi crisi economicofinanziarie, guerre e una pandemia ma è tutta una questione di lettura della condizione che si sta vivendo ad alimentare (o meno) tale sentimento. Persino in momenti bui le giovani generazioni devono tornare ad avere fiducia, per dare un contributo di evoluzione a se stessi e alla collettività».
Sì, perché non si nasce “speranzosi”, come aggiunge Mangone. «Questo percezione, tenace ma anche fragile, va coltivata, bisognerebbe gettarne il seme dentro la nostra vita e dentro la società e aspettare che dia i suoi frutti».
Professoressa Mangone, la speranza è…
Un poliedro, dalle tante facce. Come esperienza soggettiva essa si esprime sotto forma di emozione, sentimento, tratto di personalità, abito di azione, virtù. Ma anche una forma di conoscenza fino ad arrivare a essere un bene relazionale. La speranza, poi, non si sviluppa solo nelle singole persone (attese individuali, che attengono al nostro sistema di valori e scopi), ma pure tra gli individui (attese condivise, per esempio all’interno di un partito politico, di una squadra sportiva) e contro il prossimo (attese conflittuali, quando ci auguriamo che l’altro perda). Ovviamente, poi, persone e gruppi ripongono le loro aspettative in realtà diverse, nella vita oltre la morte, nella felicità in questo mondo, nella sicurezza materiale…
Al di là della singola natura, ci sono elementi presenti in azioni, esperienze o relazioni che la caratterizzano?
In qualsiasi modo la cataloghiamo, la speranza ha tratti peculiari che si ripetono. In primo luogo, è un’esperienza soggettiva: ognuno di noi ha dentro di sé una particolare e unica struttura di desideri che si affiancano, si sovrappongono, possono entrare in contrasto tra loro e inoltre mutare nel tempo in relazione ai diversi momenti della vita, ma hanno sempre una dimensione temporale proiettata al futuro. La seconda specificità è che la speranza poggia sull’anelito di un bene (l’obiettivo che il soggetto vuole raggiungere); la terza è l’attesa fiduciosa di raggiungere questo bene, che è possibile ma incerto. In qualsiasi caso, comunque, l’auspicio di qualcosa ci fornisce invariabilmente una sorta di predisposizione all’agire. La sua particolarità distintiva è che rappresenta una volontà individuale libera, nessuno ci obbliga ad ambire a questo o quello.
È indispensabile per vivere?
Rispondo come avrebbe risposto Paulo Freire, pedagogista brasiliano. La speranza è un elemento ontologico dell’essere umano, cioè una sua parte fondativa. Ci permette di leggere le diverse situazioni che viviamo – pure in modo critico – ma anche di immaginare un nuovo mondo possibile, auspicabilmente migliore. Per questo, Freire e altri studiosi aggiungono che questo sentimento di fiducia nel tempo prossimo debba essere insegnato alle nuove generazioni, soprattutto per superare condizioni di disparità sociale.
Ma attendiamo, e basta?
No, la speranza è una specie di attesa attiva, una forza che ci mette in movimento e che consente alle persone di rimanere impegnate e vigili perfino nei momenti di grande incertezza e avversità. In tal senso, può produrre un effetto normativo sui comportamenti di ciascuno di noi.
Ossia?
La speranza ha anche una natura (e forza) performativa. Non si limita ad alimentare o a dare un profilo a una certa rappresentazione della realtà nella mente, più o meno ottimistica o pessimistica, ma ha un effetto trasformativo sulla realtà poiché spinge gli individui a impegnarsi e a battersi per ottenere un certo bene o scopo. Confidare in un determinato futuro può agevolarne l’arrivo, proprio come chi va in cerca di amici mostrandosi affabile li troverà più facilmente dello scontroso oppure chi confida di superare un esame e studia bene avrà più possibilità di riuscirci, mentre chi dubita di guarire da una malattia corre un maggior rischio di soccomberle rispetto a chi non lo fa. Comportarsi come se non ci fosse possibilità di successo può finire per garantirne l’assenza.
La speranza è essa stessa un bene?
Sì, ci indirizza sempre, in qualche modo, all’autorealizzazione, concorrendo al nostro benessere. Se pensiamo alla finitudine dell’essere umano, nessuno di noi agirebbe se pensasse che ogni giorno fosse l’ultimo. Al contrario, la speranza ci fa andare avanti perché riteniamo che ci sia sempre un giorno in più per fare le nostre cose, un giorno in più per stare con gli affetti personali, un giorno in più per raggiungere una meta. Non solo, questo sentimento è anche un bene relazionale: contribuisce a creare dei legami tra le persone, che ambiscono allo stesso scopo.
È anche passione?
Rispetto alle emozioni, le passioni sono stati affettivi più strutturati e durevoli. E, infatti, la speranza non si può identificare in uno stato emozionale improvviso che ci travolge ma in uno stato affettivo più persistente che si consolida con il tempo e che può essere nutrito con un certo atteggiamento.
Dove nasce?
Ci sono tre luoghi per eccellenza nei quali si forma e si alimenta la speranza. Il primo è la nascita di un nuovo sistema d’idee: testimonia che il mondo non è destinato alla ripetizione del sempre uguale e alla decrepitezza, e questo ci rende positivi e aperti. Il secondo è la cura dell’altro, e l’esempio più lampante e pratico è il genitore che cresce un figlio. Lo fa non solo per difendere e preservarne la vita per come essa è, ma anche per cercare di realizzare la sua migliore forma possibile, cioè intenderla in una prospettiva futura. Il terzo, infine, grande luogo del sociale dove germoglia e cresce è il lavoro a cui sono collegate molti ideali umani: quello di una vita dignitosa per se stessi e la propria famiglia; la realizzazione personale e il contributo che ognuno apporta alla costruzione della società attraverso la “fattura” di prodotti e servizi utili ad altri.
Perché passione “del possibile”, come s’afferma nel titolo del libro?
La speranza è una roulette russa: ciò che vogliamo può succedere o no, il possibile è legato al livello di motivazione dell’individuo e alla volontà che ci mette nel raggiungere questo fine. Ci sprona a rimetterci in gioco in un percorso fatto anche di ansie, paure, dubbi, delusioni e disillusioni. Con traiettorie plurime: ogni volta che agiamo, siamo pronti a trovare qualcosa di nuovo, di noi, degli altri, del mondo. La speranza, infatti, è dinamicità, prassi, azione. Se non fosse così, le grandi scoperte scientifiche non ci sarebbero state e nemmeno il progresso.
Speranza, un sentimento che non ha età
La speranza non dovrebbe abbandonarci mai? «Sì, deve essere di tutti, e non solo delle classi giovani», risponde la professoressa Mangone. «È vero che è rivolta al futuro, con gli anni sempre più di breve termine, ma è altrettanto vero che è il passaggio di testimone ad azzerare le differenze anagrafiche. Infatti, se i giovani ripongono le loro speranze portando avanti direttamente i loro progetti di vita, gli over 60 possono proiettarle stando vicino a chi ha tanti anni meno di loro».
Fai la tua domanda ai nostri esperti