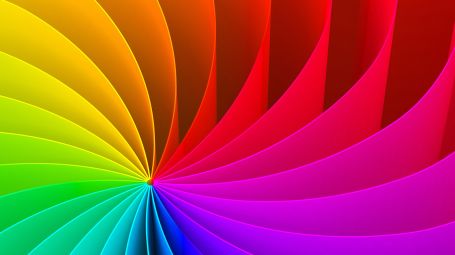La vita di ogni giorno è un appassionante mosaico di tinte e sfumature, che contribuiscono a evocare emozioni, stimolare la creatività e influenzare il nostro stato d’animo. Tuttavia, ci sono alterazioni della percezione cromatica che possono ostacolare il corretto riconoscimento di alcuni colori, incidendo su attività quotidiane come la scelta degli abiti, la lettura dei segnali stradali o l’interpretazione di grafici e mappe.
«Si parla di discromatopsia quando alcune cellule altamente specializzate presenti nella retina, i coni, non funzionano correttamente», spiega il dottor Franco Spedale, chirurgo oculista, direttore del reparto di Oculistica dell’Ospedale di Chiari, Brescia.
Come vediamo i colori
La luce visibile è composta da onde elettromagnetiche con diverse lunghezze d’onda: lunghe, medie e corte. Ogni colore che vediamo è il risultato di una lunghezza d’onda specifica che stimola i coni, permettendo al cervello di percepire quel determinato colore.
«Ad esempio, una lunghezza d’onda intorno ai 480 nanometri viene percepita come blu, intorno ai 650 nanometri come rosso e intorno ai 520 nanometri come verde», evidenzia il dottor Spedale. «A consentire questa conversione sono proprio i coni, circa sei milioni per ogni occhio, che determinano la nostra visione in presenza di luce intensa, quindi durante il giorno o in presenza di illuminazione artificiale».
Esistono tre tipi di coni, ciascuno sensibile a una diversa gamma di lunghezze d’onda della luce: «Quando quest’ultima li colpisce, i pigmenti presenti al loro interno si attivano, generando dei segnali elettrici», descrive il dottor Spedale. «Attraverso il nervo ottico, questi segnali vengono poi trasmessi al cervello, che elabora le informazioni e le combina per creare la percezione di una vasta gamma di colori». Se i coni presentano alterazioni qualitative o quantitative, cioè funzionano male o sono presenti in numero ridotto, la capacità di percepire i colori corrispondenti risulta limitata.
Quali sono le cause della discromatopsia
La discromatopsia può essere congenita: «In questo caso, la causa principale è un difetto nei geni che controllano la produzione di uno o più tipi di coni nella retina», specifica l’esperto. «Siccome questi geni si trovano principalmente nel cromosoma X, il disturbo è più comune nei maschi, che hanno un solo cromosoma X, rispetto alle femmine, che ne hanno due».
Altre volte, invece, il difetto è acquisito, cioè secondario a traumi o malattie che danneggiano la retina o il nervo ottico, degenerazione maculare legata all’età, diabete, glaucoma, patologie neurologiche o alcuni medicinali assunti per un lungo periodo di tempo.
Quali sono i sintomi della discromatopsia
La forma più comune di discromatopsia è causata da un difetto nei coni sensibili al rosso o al verde, per cui risulta compromessa la percezione di questi due colori. Più rara è quella a carico dei coni sensibili al blu, da cui risulta una ha difficoltà a distinguere sia il blu sia il giallo. In casi estremi, una persona può avere solo uno dei tre tipi di coni (o persino nessuno) e questo può portare a una visione del colore molto limitata o addirittura alla monocromia, dove il mondo viene visto solo in bianco e nero o in tonalità di grigio.
«Pensiamo alle comuni stampanti che abbiamo a casa o in ufficio», semplifica il dottor Spedale. «Ciano, magenta e giallo sono gli inchiostri primari utilizzati e la loro combinazione nelle giuste proporzioni può produrre una vasta gamma di colori. Quando una delle cartucce finisce, le stampe risultano sbiadite o addirittura monocromatiche. È quello che accade nei nostri occhi se mancano i coni corrispondenti a determinati colori. Mentre nelle forme congenite l’alterazione riguarda entrambi gli occhi, di solito quelle acquisite sono monolaterali».
Quali sono le conseguenze della discromatopsia
La discromatopsia bilaterale benigna, comunemente chiamata daltonismo, non è una condizione pericolosa per la salute oculare e, di conseguenza, non è associata a un deterioramento della vista o a malattie oculari più gravi. L’unica conseguenza è una possibile limitazione nella vita quotidiana.
Per esempio, esistono professioni in cui una percezione accurata dei colori è fondamentale e dove le alterazioni cromatiche possono rappresentare un ostacolo significativo: piloti, elettricisti, designer, artisti, decoratori e medici di laboratorio sono solamente alcuni dei mestieri in cui la capacità di distinguere tra diversi colori è importante per operare in sicurezza, mantenere standard di qualità o interpretare dei risultati.
«Attenzione, però», tiene a precisare il dottor Spedale. «Anche se in genere si tratta di una condizione benigna e non associata a rischi diretti per la salute visiva, qualora si sperimenti una perdita improvvisa o significativa della visione dei colori, è bene sottoporsi tempestivamente a un controllo oculistico per escludere patologie oculari o neurologiche, che potrebbero essere causa dell’alterazione».
Come si diagnostica la discromatopsia
La discromatopsia viene diagnosticata tramite una serie di test visivi che permettono di valutare la capacità di distinguere i colori. I più comuni sono i test di Ishihara, che consistono in una serie di tavole con numeri o figure disegnati usando una combinazione di punti colorati.
«Le persone con discromatopsia non riescono a vedere correttamente i numeri o le figure se il disturbo è presente, a causa della difficoltà a distinguere tra colori simili come il rosso e il verde», illustra il dottor Spedale.
Si può ricorrere anche al Test Farnsworth Munsell 100 Hue, dove bisogna ordinare una serie di dischi colorati in base alla tonalità del colore, dal più simile al più diverso.
Come si cura la discromatopsia
Al momento non esistono terapie per la discromatopsia congenita. Chi ne soffre può imparare a riconoscere i colori attraverso l’uso di indizi contestuali, come la posizione degli oggetti o l’utilizzo di etichette.
Esistono anche app per smartphone che offrono un supporto pratico, rilevando i colori e descrivendoli vocalmente o visivamente, ma c’è anche chi trova utile l’uso di occhiali o lenti a contatto con filtri colorati che permettono di migliorare il contrasto cromatico tra alcuni colori.
«Nelle forme acquisite, invece, si cerca di trattare la causa di base, quando possibile», conclude il dottor Spedale. «Se il problema che ha determinato la discromatopsia non è troppo severo, la situazione è del tutto reversibile».
Fai la tua domanda ai nostri esperti