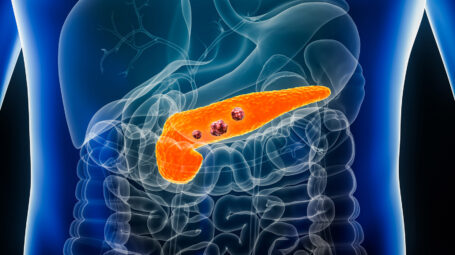Nell’immaginario collettivo, gli organi interni vengono spesso visualizzati come strutture uniformi, ma la realtà anatomica è molto più complessa. Il pancreas, ad esempio, può presentare irregolarità, piccole formazioni o rilievi che, grazie ai progressi della diagnostica per immagini, vengono individuati con crescente precisione. Tra queste alterazioni, le cisti pancreatiche rappresentano una condizione particolare: per lo più asintomatiche, talvolta fonte di preoccupazione, raramente urgenti, ma sempre meritevoli di un attento monitoraggio.
«L’apparente aumento dell’incidenza delle cisti pancreatiche è in realtà il risultato di un miglioramento significativo dell’attività diagnostica», spiega il professor Vittorio Gallo, gastroenterologo del CeMeDi di Torino. «Fino a pochi anni fa, cisti e tumori del pancreas venivano spesso identificati in fase avanzata, quando le opzioni terapeutiche erano ormai limitate. Oggi invece, grazie all’impiego sempre più diffuso di ecografie, risonanze magnetiche e Tc, è possibile individuarli in fase precoce, aprendo la strada a un monitoraggio o a un intervento tempestivo».
Una scoperta spesso accidentale
La maggior parte delle cisti pancreatiche viene individuata in modo del tutto incidentale. È frequente che vengano rilevate durante un’ecografia eseguita per altri motivi, come patologie epatiche, renali o biliari, nel contesto di un controllo di routine. Solo raramente sono i sintomi a condurre direttamente alla diagnosi: dolore addominale, lieve ittero, calo di peso e stanchezza cronica tendono a comparire in fase più avanzata.
«Il pancreas è un organo particolarmente insidioso sia per la sua posizione anatomica, nascosto dietro e sotto lo stomaco e avvolto dal duodeno, sia per la capacità che ha di mascherare i propri disturbi dietro sintomi comuni ad altri apparati», osserva il professor Gallo.
Non sorprende, quindi, che una cisti pancreatica possa restare silente e inosservata per anni, fino a raggiungere dimensioni significative o interferire con la normale funzionalità dell’organo.
Cisti e pseudocisti: cosa sono e come si distinguono
Cisti pancreatica è un’espressione generica che racchiude condizioni diverse tra loro. Una distinzione fondamentale è quella tra cisti e pseudocisti. Le seconde si formano solitamente come conseguenza di pancreatiti acute e sono raccolte liquide, spesso localizzate anche al di fuori del pancreas, e sono generalmente benigne. Possono tuttavia diventare sintomatiche se raggiungono dimensioni considerevoli o comprimono le strutture vicine. «Si evidenziano molto bene con l’ecografia e la risonanza magnetica, soprattutto quando si riconduce il riscontro a un episodio noto di pancreatite», sottolinea il professor Gallo.
Le cisti propriamente dette, invece, originano all’interno del pancreas e comprendono varie tipologie, ciascuna con caratteristiche e implicazioni cliniche differenti. Tra queste, le neoplasie cistiche sierose (SCN) sono considerate le più innocue: si presentano come formazioni piene di un liquido chiaro, poco denso, e raramente causano sintomi, se non in caso di compressione meccanica dovuta al volume.
Più complesse e potenzialmente più insidiose sono le neoplasie cistiche mucinose (MCN). Tipiche del sesso femminile, soprattutto dopo i 40, queste lesioni rappresentano una condizione premaligna: pur non essendo tumori in senso stretto, possono evolvere nel tempo verso una trasformazione neoplastica. «La mucina è una sostanza densa e viscosa prodotta dal pancreas», spiega l’esperto, «e il suo accumulo all’interno della cisti può alterarne il comportamento biologico». Anche in assenza di sintomi, queste formazioni devono essere monitorate con attenzione e, in alcuni casi, trattate chirurgicamente.
Infine, il gruppo più numeroso è rappresentato dalle neoplasie intraduttali papillari mucinose (IPMN), che si sviluppano in stretta connessione con i dotti pancreatici, i canali attraverso cui gli enzimi digestivi prodotti dal pancreas vengono convogliati nel duodeno. «Il pancreas è attraversato da una rete complessa di dotti», ricorda il professor Gallo, «il cui compito è raccogliere e trasportare i succhi pancreatici, ricchi di enzimi essenziali per la digestione di determinati nutrienti».
Le IPMN si formano proprio in prossimità di queste strutture e, a seconda del dotto coinvolto, si suddividono in sottotipi con differenti rischi evolutivi:
- IPMN del dotto principale, che interessano il dotto pancreatico principale, chiamato dotto di Wirsung, il canale centrale che attraversa l’intera ghiandola, paragonabile a un grande fiume. Sono considerate le più a rischio di trasformazione maligna e richiedono una sorveglianza più attenta;
- IPMN dei dotti secondari, che coinvolgono i dotti laterali, paragonabili ai rami di un albero spoglio o agli affluenti del fiume principale. Hanno un rischio inferiore, ma non trascurabile;
- IPMN misti, che comprendono alterazioni sia del dotto principale sia dei dotti secondari, combinando quindi caratteristiche e rischi di entrambe le forme.
«Le IPMN del dotto principale sono quelle che preoccupano di più per la loro potenziale trasformazione maligna», sottolinea il professor Gallo. Quelle branch type, invece, hanno un rischio più basso, ma devono comunque essere tenute sotto controllo.
Quali sono le cause delle cisti pancreatiche
Le cause delle cisti pancreatiche possono essere molteplici e, in diversi casi, non perfettamente definibili. «Tra i fattori più frequentemente associati si includono l'abuso di alcol, un'alimentazione squilibrata e l'esposizione a sostanze tossiche ambientali», indica il professor Gallo. «Anche alcuni farmaci, noti per avere effetti collaterali a carico del pancreas, possono essere coinvolti nello sviluppo di queste lesioni, sebbene i meccanismi non siano sempre completamente chiariti».
Talvolta le cisti possono derivare da processi infiammatori cronici o da pregresse pancreatiti, mentre in altri si formano in assenza di un’anamnesi clinicamente significativa, suggerendo la possibile presenza di fattori predisponenti ancora poco compresi.
La natura multifattoriale del fenomeno rende complessa l’individuazione di una causa unica e universale. «Ciò che è certo», riflette l’esperto, «è che la presenza di cisti e pseudocisti pancreatiche interessa circa il 2% della popolazione generale: una percentuale che, se applicata a contesti urbani ad alta densità, assume un rilievo epidemiologico non trascurabile».
Quali sono i sintomi delle cisti pancreatiche
Soprattutto nelle fasi iniziali, le cisti pancreatiche possono rimanere a lungo silenti e asintomatiche. Tuttavia, quando i sintomi si manifestano, è fondamentale riconoscerli tempestivamente poiché possono rappresentare un campanello d’allarme per alterazioni funzionali o strutturali del pancreas.
«Uno dei sintomi più frequenti è il dolore addominale, localizzato nella parte superiore dell’addome, spesso irradiato posteriormente», tiene a precisare il professor Gallo. «Questo dolore può essere facilmente confuso con disturbi gastrici o con problematiche delle vie biliari, come la presenza di calcoli. Proprio per la sua natura aspecifica, può inizialmente essere sottovalutato o attribuito ad altre cause più comuni».
Con l’aumento di volume delle cisti, soprattutto quando localizzate nella testa del pancreas, possono insorgere sintomi legati alla compressione delle strutture adiacenti, in particolare della via biliare principale. «In questi casi si può sviluppare ittero ostruttivo, una condizione in cui la bile non riesce più a defluire correttamente, determinando un ingiallimento della pelle e delle sclere oculari», aggiunge l’esperto. «Questo segno clinico è spesso associato a lesioni di dimensioni rilevanti o a neoplasie cistiche che crescono fino a ostacolare il passaggio biliare».
Tra gli altri sintomi non specifici ma potenzialmente indicativi, si segnalano la perdita di peso inspiegata, la stanchezza cronica e l’inappetenza. Sebbene non siano sintomi esclusivi del pancreas, la loro comparsa in soggetti che non presentano una storia clinica significativa pregressa dovrebbe sollevare sospetti e motivare un approfondimento diagnostico.
Un altro elemento da considerare è l’alterazione delle funzioni digestive. In presenza di cisti che compromettono la normale secrezione enzimatica del pancreas, si può assistere a una digestione incompleta dei grassi. «Questo si traduce nella comparsa di feci più sfatte, oleose o difficili da eliminare, una condizione nota come steatorrea», indica il professor Gallo. Anche questo segnale può indicare una compromissione della funzione esocrina dell’organo.
Quando preoccuparsi
Molti pazienti scoprono di avere una cisti pancreatica e si domandano se e quanto debbano preoccuparsi. La risposta dipende da diversi fattori: innanzitutto le dimensioni, la presenza di sintomi e alcune caratteristiche morfologiche. «In generale, si consiglia la sorveglianza a vita per tutte le cisti non ben definite e per le IPMN branch type asintomatiche inferiori a 3 cm», indica il professor Gallo.
«Se invece superano i 4 cm o se tra i 3 e i 4 cm presentano noduli solidi o calcificazioni, il rischio aumenta. In generale, uno dei criteri fondamentali che ci guida è la crescita nel tempo: una cisti che aumenta di oltre 5 mm in un anno deve far scattare l’allerta». Altri indicatori importanti sono l’aumento del valore del marcatore tumorale CA 19-9 (sopra le 37 unità/ml) e la dilatazione del dotto pancreatico principale oltre i 9,9 mm.
Quali esami sono indicati
La sorveglianza delle cisti pancreatiche si basa su una batteria di esami. «L’ecografia addominale resta il primo strumento di screening, ma per una diagnosi più precisa si ricorre alla colangio-risonanza magnetica (colangio-RM) che offre immagini più dettagliate dei dotti pancreatici. In casi selezionati, soprattutto quando si sospetta una trasformazione maligna, si può ricorrere anche all’ecoendoscopia, una tecnica diagnostica che combina l’endoscopia con l’ecografia e consente di osservare il pancreas senza l’interposizione della parete addominale, permettendo – se necessario – di effettuare biopsie mirate.
A tutto ciò si aggiungono gli esami ematochimici: dosaggio di amilasi, lipasi, elastasi fecale e del marcatore CA 19-9. «La funzione pancreatica deve sempre essere valutata in presenza di una cisti, sia per l’aspetto digestivo sia per quello endocrino», spiega il professor Gallo. Il diabete, infatti, può essere un sintomo di esordio.
Quando è necessario intervenire
Non tutte le cisti richiedono un approccio chirurgico, ma alcune condizioni impongono un’attenta valutazione. Le IPMN del dotto principale, le forme miste e le MCN sopra i 4 cm sono le più frequentemente sottoposte a resezione. Anche le branch type possono essere operate se sintomatiche, di grandi dimensioni o con crescita rapida.
«Il nostro compito è distinguere le situazioni che richiedono solo un monitoraggio da quelle che vanno inviate al chirurgo specializzato in pancreas e vie biliari», chiarisce il professor Gallo. «In ogni caso, il trattamento è sempre personalizzato, basato sul bilancio tra rischi e benefici».
Come si prevengono le cisti pancreatiche
Non potendo agire direttamente sulle cause – che restano in parte sconosciute e includono fattori ambientali, farmacologici e forse genetici – la prevenzione delle complicanze passa attraverso la diagnosi precoce. «Dai 55 anni in su, tutti dovrebbero sottoporsi ad almeno un'ecografia addominale ogni anno, come si fa con altri esami di screening», suggerisce il professor Gallo. «Con l’ecografia possiamo vedere fegato, reni, cistifellea, grossi vasi e pancreas: è uno strumento potente, che può davvero salvare la vita».
Il pancreas è un organo silenzioso, spesso trascurato perché non dà segnali evidenti fino a quando la situazione non è avanzata. Eppure, riconoscerne per tempo i segnali può fare la differenza tra un semplice monitoraggio e l’evoluzione verso una patologia complessa. «Le cisti pancreatiche, nella maggior parte dei casi, non sono motivo di allarme», conclude il professor Gallo, «ma vanno affrontate con serietà, competenza e uno sguardo clinico sempre attento».
Fai la tua domanda ai nostri esperti