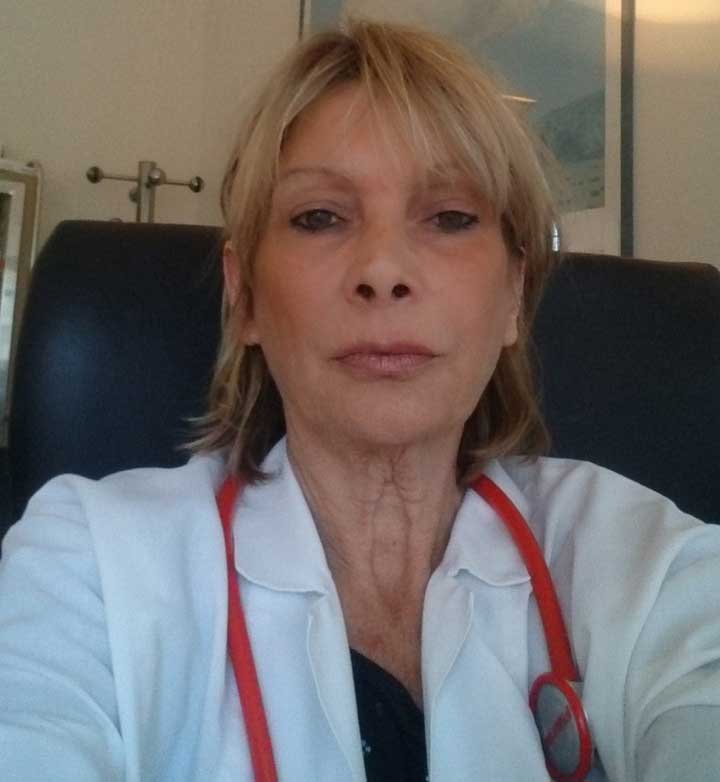D’estate, il caldo e gli abiti più leggeri fanno emergere una verità nascosta, spesso silenziosa e invisibile: il rapporto con il nostro corpo. Le occasioni sociali aumentano, ci esponiamo di più, ci guardiamo di più. E veniamo guardati. È proprio in questi momenti che il confronto tra “come siamo” e “come pensiamo di apparire” si fa più acceso.
Quello che proviamo non è sempre e solo un generico “non piacerci”. A volte c’è qualcosa di più profondo, disturbante, doloroso. È il caso della dispercezione corporea, un fenomeno complesso e sfaccettato, che si colloca a metà strada tra il disagio e la sofferenza psicopatologica.
Cos’è la dispercezione corporea
La dispercezione corporea è un sintomo, un segnale che qualcosa non va non solo nel modo in cui ci vediamo allo specchio, ma anche in quello di percepirci e di stare al mondo. «È una distorsione della percezione del proprio corpo, che può assumere livelli diversi di intensità», spiega il dottor Alessandro Raggi, psicoterapeuta e vice presidente della Fondazione Ananke di Villa Miralago. «Talvolta è passeggera, legata a un momento specifico della vita, mentre in altri casi può essere così marcata da compromettere seriamente la qualità di vita».
Nel parlare comune, si tende spesso a usare termini come “percezione corporea” o “dismorfofobia” come se fossero la stessa cosa. In realtà, per chi lavora in ambito clinico, esistono differenze importanti: «La dismorfofobia è più estrema: un pensiero fisso su un dettaglio fisico, anche minimo, che diventa un’ossessione», descrive l’esperto. «In fondo, entrambe raccontano di quanto possa fare male il modo in cui sentiamo e giudichiamo il nostro corpo. In questo contesto, però, possiamo usare il termine “dispercezione” in senso più ampio, per indicare quel disagio profondo che nasce dal sentirsi inadeguati nel proprio corpo, anche senza difetti reali. Un sentire che può diventare invasivo, doloroso e difficile da spiegare a chi non lo ha mai provato».
Nel suo significato clinico, la dispercezione corporea – o, in forme più gravi, la dismorfofobia – è spesso associata a disturbi psicopatologici come quelli del comportamento alimentare – anoressia, bulimia, binge eating – oppure a disturbi ossessivi, ansiosi, fino ad arrivare, nei casi più estremi, a forme di grave alterazione del rapporto con la realtà.
Quali sono le cause della dispercezione corporea
Non esiste una causa unica per la dispercezione corporea, ma alcuni elementi possono predisporre a questo tipo di disagio: una fragilità nell’autostima, una struttura identitaria instabile, esperienze di esclusione, abbandono o abuso (che non devono essere necessariamente fisici o sessuali: anche il bullismo o un ambiente familiare ipercritico, giudicante e svalutante possono lasciare cicatrici profonde).
L’adolescenza è certamente un periodo critico: il corpo cambia, si trasforma e, con esso, l’identità. È un passaggio necessario ma delicato, in cui l’immagine corporea è spesso instabile e influenzata dal giudizio degli altri. In assenza di strumenti emotivi adeguati, il rischio di sviluppare una dispercezione è molto alto.
«Il corpo non è solo materia, ma anche simbolo», aggiunge il dottor Raggi. «È veicolo dell’identità, terreno su cui si scrive chi siamo. Per molti, l’identità è un insieme composito: il lavoro che svolgiamo, i nostri interessi, le relazioni affettive. Per alcune persone, invece, il corpo ne diventa il fulcro centrale. Una centralità che nasce spesso da interruzioni nello sviluppo, traumi affettivi, esperienze di abbandono, bullismo o anche dalla mancanza di uno spazio sicuro in cui costruire la propria immagine».
Chi sviluppa una dispercezione corporea, infatti, ha frequentemente vissuto esperienze che hanno minato la possibilità di fare riferimento a risorse interiori diverse dal corpo per definire se stessi. Quando l’unica ancora diventa l’esteriorità, ogni imperfezione percepita si trasforma in un fallimento, in una minaccia all’intera identità. «Il corpo smette di essere parte di sé e diventa qualcosa da controllare, punire, modificare, nascondere oppure, nei casi più gravi, da odiare», ammette lo psicoterapeuta.
A rendere più difficile il rapporto contribuisce un immaginario collettivo fatto di corpi perfetti, levigati, eternamente giovani. I social media, in particolare, alimentano aspettative irrealistiche e standard estetici omologanti. L’unicità del corpo reale, con i suoi difetti, le sue curve, le sue asimmetrie, viene percepita come una colpa. La bellezza si trasforma in un’ossessione.
Molti adolescenti – ma anche adulti – interiorizzano l’idea che esista un solo modo di essere belli e desiderabili. E se il proprio corpo non rientra in quel modello, allora si è sbagliati. È così che nasce la dispercezione: non come atto di vanità, ma come tragedia del confronto, come rifiuto di un sé che non corrisponde a ciò che si pensa di dover essere.
Come si manifesta la dispercezione corporea
È altrettanto importante chiarire cosa non è la dispercezione corporea. Non si tratta di allucinazioni: non parliamo di vedere qualcosa che non c’è, ma di percepire in modo alterato qualcosa che esiste. «Una persona magra può percepirsi grassa, ma non perché “vede” chili in più, bensì perché si sente sproporzionata, inadeguata, sformata», specifica il dottor Raggi. «La realtà viene filtrata da uno stato emotivo alterato, da una storia personale, da un dolore che si incarna».
Può capitare a tutti, in momenti di particolare fragilità, di non riconoscersi, di sentirsi gonfi, appesantiti, brutti, anche senza reali modificazioni del corpo. «Se questa sensazione diventa cronica, quando il disagio supera la soglia della quotidianità, ci troviamo davanti a una forma più grave e persistente, che può sfociare proprio nella dispercezione corporea», illustra l’esperto. «È la convinzione ossessiva di avere un difetto fisico, anche minimo o inesistente, che rovina completamente la percezione del proprio valore».
Il corpo come “pattumiera”
Le parole usate da chi soffre di dispercezione corporea sono spesso violente. “Mi faccio schifo”, “Sono una palla di grasso”. Sono frasi che raccontano un odio profondo, non verso qualcosa che si ha, ma verso qualcosa che si è. «In questi casi, il corpo non è solo rifiutato, ma disprezzato», dice il dottor Raggi. «Diventa uno “scarto”, qualcosa da allontanare, nascondere, maltrattare. E a quel punto il dolore psicologico si traduce in comportamenti concreti: abbuffate, vomito, digiuni, uso eccessivo di esercizio fisico, isolamento sociale».
Chi si percepisce come un oggetto di disprezzo finisce per trattarsi come tale. Il corpo viene punito, trascurato, abusato. Ed è qui che il sintomo psicologico inizia ad avere conseguenze reali e tangibili anche sulla salute fisica. Non si tratta solo di avere insicurezze circa il proprio aspetto fisico, ma di vivere un corpo che fa male, che viene trasformato in prigione e nemico.
Cosa fare
Il primo passo per affrontare la dispercezione corporea è riconoscerla. Non sminuire il disagio, non liquidarlo con un “ma quando mai, sei così carino!”. Le frasi dette con leggerezza possono ferire. «Se un figlio, un amico, un partner ci dice che si sente brutto o sbagliato, non dobbiamo correggerlo, ma ascoltarlo», suggerisce lo psicoterapeuta. «Dobbiamo accogliere la sofferenza, anche se ci sembra esagerata. Per esempio, dire “deve essere difficile sentirsi così, raccontami di più” crea uno spazio sicuro in cui la persona può aprirsi e sentirsi capita».
Nei casi in cui il disagio persiste e compromette la vita quotidiana, è necessario un intervento specialistico. Una delle tecniche più efficaci nel trattamento della dispercezione corporea è la terapia dello specchio, un protocollo psicoterapeutico strutturato – messo a punto in Italia dalla psichiatra Laura Dalla Ragione – che guida il paziente in un percorso graduale di riappropriazione della propria immagine corporea. In un numero limitato di sedute, lo specchio diventa uno strumento per imparare a guardarsi davvero, senza le lenti deformanti del giudizio o dell’ideale.
«È un metodo strutturato, ancora poco diffuso in Italia, ma che applichiamo con successo nella comunità di Villa Miralago, vicino a Varese, in un contesto clinico altamente specializzato, eccellenza del nostro Ssn», precisa il dottor Raggi.
Si parte da singole parti del corpo, per arrivare a un’immagine più globale e realistica. «L’obiettivo non è trovare la bellezza, ma accettare la realtà, con le sue peculiarità», descrive l’esperto. «Studi clinici mostrano che nei disturbi alimentari, ad esempio, la percezione delle dimensioni corporee può essere talmente distorta che una persona magra può immaginare la propria gamba il doppio delle sue reali misure. Davanti allo specchio, guidati da uno psicoterapeuta, questi inganni si sciolgono lentamente».
Ma la terapia dello specchio non funziona da sola. Va inserita in un percorso più ampio, che può includere terapia psicologica individuale, gruppi di sostegno, interventi nutrizionali e, nei casi più gravi, supporto medico. «Ogni ferita può essere curata, se viene riconosciuta e ascoltata», conclude il dottor Raggi. «Il corpo non è un nemico da combattere, ma un compagno da comprendere. E forse, con il tempo, anche da amare».
Fai la tua domanda ai nostri esperti