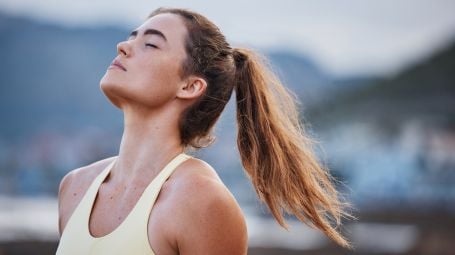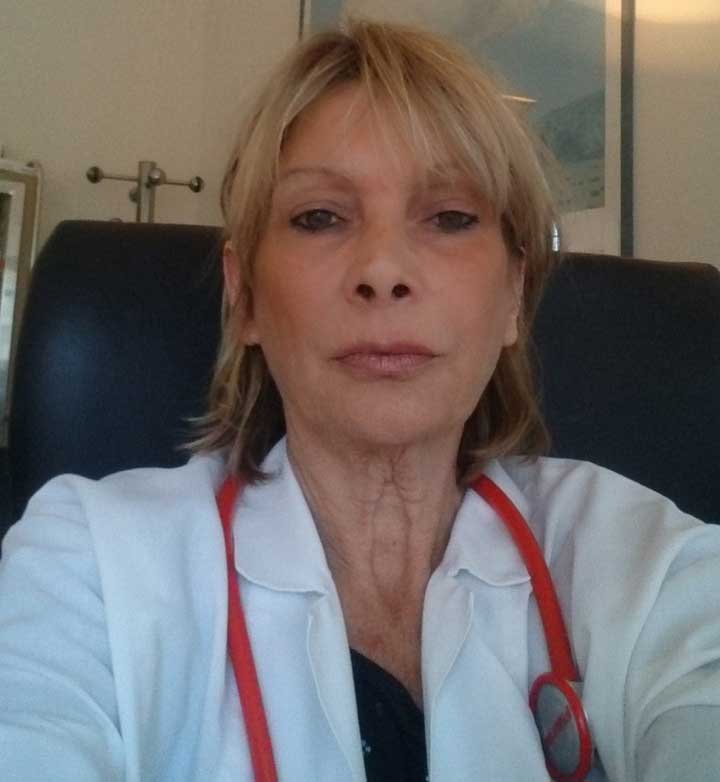Social prescribing: le attività ricreative come cura
I farmaci non sono l’unica soluzione per affrontare le malattie. Disturbi come ansia e depressione, ma anche patologie complesse come tumori e demenze, possono trarre beneficio dall’indicazione medica di attività ricreative come parte integrante del percorso terapeutico

Se avesse sentito parlare del social prescribing, Bridget Jones avrebbe abbandonato il divano per seguire il consiglio del medico: frequentare un gruppo di lettura, un corso di ceramica o una passeggiata guidata al parco. E magari, chissà, avrebbe dimenticato Daniel Cleaver molto prima. Sembra l’incipit di una commedia romantica, invece è realtà. Oggi la scienza sta abbracciando una nuova consapevolezza, secondo cui non tutto si risolve con una pillola.
I passatempi che curano corpo e mente
Il social prescribing – tradotto, “prescrizione sociale” – è un approccio innovativo alla cura, che indirizza i pazienti verso attività non cliniche ma ad alto impatto sul benessere psicofisico: laboratori artistici, gruppi di volontariato, orti urbani, corsi sportivi, mindfulness, musicoterapia e molto altro.
Secondo uno studio pubblicato nel 2019 sul British Medical Journal, questa strategia può ridurre significativamente la solitudine – oggi riconosciuta come un fattore di rischio per numerose patologie croniche – e contribuire a diminuire visite mediche, accessi ospedalieri e uso improprio di farmaci.
Il beneficio non si limita ai casi di ansia o depressione: si è dimostrato utile anche per chi convive con patologie croniche, oncologiche o neurologiche, perché aiuta a sentirsi parte di una rete, più motivati a seguire le cure e più resilienti di fronte alla malattia.
Social prescribing, in Inghilterra è realtà
Le esperienze più consolidate si trovano nel Regno Unito, dove il social prescribing è parte integrante del sistema sanitario. «Nel modello anglosassone, in particolare, esiste addirittura una figura professionale dedicata, il link worker, un facilitatore che fa da ponte tra il medico prescrittore e la rete di soggetti accreditati che offrono le attività», spiega il professor Antonio De Belvis, epidemiologo e responsabile della UOC Percorsi e Valutazione Outcome Clinici del Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS di Roma.
«In Italia, questa figura non esiste ancora, ma stanno emergendo alcune esperienze pilota, come quella promossa dall’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, che sta formando dei link worker italiani, spesso provenienti dall’ambito sociosanitario per garantire competenza clinica».
Le basi scientifiche del social prescribing
Il social prescribing non è un semplice invito a “farsi una passeggiata” o “uscire con gli amici”, ma un intervento strutturato, basato su attività selezionate perché validate dalla ricerca scientifica. È un approccio evidence-based, cioè fondato su prove concrete della loro efficacia: le attività prescritte devono dimostrare, attraverso studi rigorosi, di migliorare la qualità di vita, ridurre i sintomi, prevenire malattie e generare benefici anche in termini di sostenibilità per il sistema sanitario.
«In quest’ottica», sottolinea De Belvis, «il Centro nazionale per la prevenzione delle malattie e la promozione della salute dell’Istituto superiore di sanità ha avviato una rete per coordinare e valorizzare le esperienze esistenti, con l’obiettivo di riconoscere ufficialmente gli interventi efficaci e integrarli nei percorsi di cura accreditati».
Le esperienze di social prescribing in Italia
Un esempio concreto arriva dalla Breast Unit del Policlinico Gemelli, guidata dal professor Gianluca Franceschini, ordinario di Chirurgia generale presso l’Università Cattolica. In sinergia con l’Associazione Komen Italia, fondata dal professor Riccardo Masetti, e con il coordinamento del dottor Stefano Magno, responsabile dell’Unità Terapie integrate in senologia, viene adottato sistematicamente il social prescribing per le pazienti operate al seno.
Questo modello accompagna le donne nel recupero post-operatorio con interventi personalizzati di mindfulness, Qi-gong, agopuntura, passeggiate terapeutiche e musicoterapia. Un altro progetto innovativo è MediCinema, che porta il cinema negli ospedali come intervento terapeutico. L’iniziativa – accreditata in strutture come il Policlinico Gemelli, il Gaslini e il Niguarda – propone interventi personalizzati: la scelta del film, ad esempio, deve essere coerente con lo stato emotivo del paziente, evitando contenuti che potrebbero aumentare il disagio.
«Gli studi effettuati affermano che la cineterapia non solo migliora la qualità della vita del malato, ma può avere un ruolo rilevante sui tempi di guarigione», assicura De Belvis. Altri esempi di collegamento tra servizi sanitari e mondo culturale sono la rete Musei Toscani per l’Alzheimer, che propone attività dedicate a persone con demenza e ai loro caregiver, e il progetto Dance Well, nato a Bassano del Grappa – ma oggi esteso a numerose realtà italiane e internazionali – che coinvolge attraverso la danza le persone che convivono con il Parkinson o altri disturbi del movimento.
Social prescribing, utile anche per prevenire
Il social prescribing ha un enorme potenziale anche in ambito preventivo. Può essere utilizzato per mantenere le persone in salute, agendo prima che si sviluppino condizioni cliniche più gravi. Questo approccio favorisce una demedicalizzazione intelligente della cura: si tratta di spostare il focus dal trattamento specialistico alla valorizzazione delle risorse già presenti nella comunità – come centri culturali, biblioteche, associazioni – che spesso restano inutilizzate, mentre possono offrire supporto concreto e inclusivo.
«Pensiamo agli anziani soli, agli adolescenti alle prese con l’ansia o alle persone con fattori di rischio come ipertensione, obesità o sindrome metabolica», continua De Belvis. «In questi casi, proporre attività sociali o ricreative può evitare una medicalizzazione precoce, intervenendo su problemi che hanno spesso una radice psicosociale, più che clinica».
I luoghi di socialità luoghi di cura
Il messaggio è semplice, ma rivoluzionario: la salute non si costruisce solo negli ospedali, ma anche nei luoghi di socialità, cultura e relazione. In un’epoca dove la solitudine è riconosciuta come emergenza sanitaria globale – con effetti simili al fumo di sigaretta o alla sedentarietà – ricostruire legami attraverso esperienze condivise è un atto terapeutico a tutti gli effetti.
«Il social prescribing non è una moda passeggera, ma un cambio di paradigma che richiede una visione politica e organizzativa», evidenzia De Belvis.
Servono modelli replicabili, risorse stabili, una formazione adeguata per medici e operatori, una collaborazione solida tra sanità pubblica, terzo settore e mondo culturale. La prossima sfida sarà integrare questi interventi nei Livelli essenziali di assistenza, perché diventino accessibili a tutti. «A volte, per stare meglio, servono solo una risata a teatro o una camminata nel verde», conclude l’esperto.
Un aiuto per le neo-mamme
Il progetto Music and Motherhood, promosso dall’Ufficio regionale per l’Europa dell’Organizzazione mondiale della sanità e coordinato in Italia dall’Istituto superiore di sanità, mostra come il canto di gruppo possa prevenire o alleviare la depressione post-partum.
Cantare insieme favorisce il benessere psico-emotivo, riduce la solitudine, migliora l’interazione madrebambino e rappresenta una modalità assistenziale sostenibile, inclusiva anche per le donne straniere. I risultati della prima fase (2021- 2023), condotta in Italia, Danimarca e Romania, sono stati pubblicati su Frontiers in Medicine ed è in sviluppo una guida pratica per operatori sanitari e culturali per rendere il modello replicabile su scala nazionale.
«La dimensione collettiva è fondamentale: non è semplicemente “fare qualcosa”, ma farlo insieme ad altri, creando relazioni, riducendo la solitudine», riferisce il professor Antonio De Belvis.
Fai la tua domanda ai nostri esperti