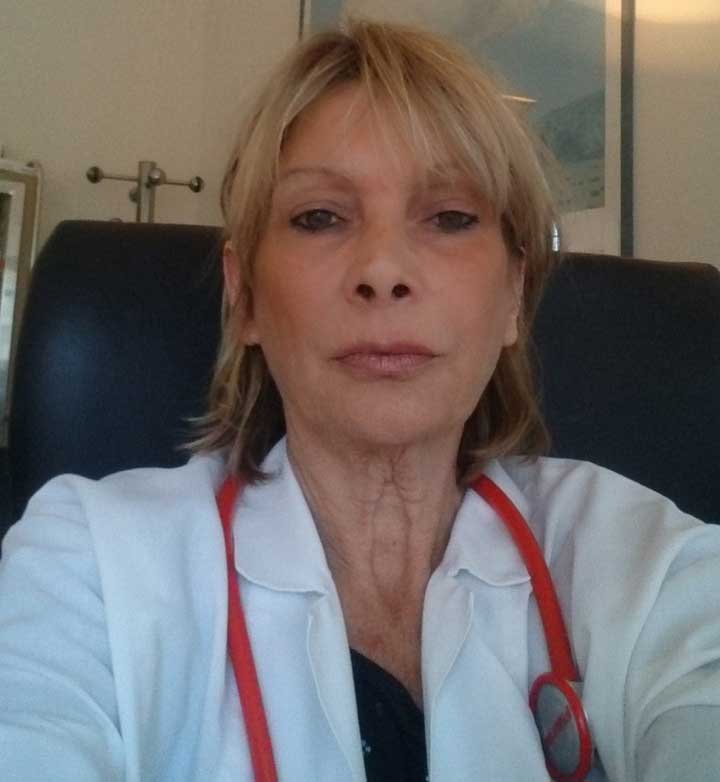Sindrome di Ekbom: cos’è, cause, sintomi, cure
Questo disturbo psichiatrico raro e complesso è caratterizzato dalla convinzione incrollabile di essere infestati da parassiti, nonostante l’assenza di riscontri medici. I sintomi, prevalentemente cutanei, si accompagnano a comportamenti compulsivi e a un profondo disagio psicologico

Esiste una condizione rara e angosciante dove il corpo diventa teatro di un’invasione immaginaria. Chi ne soffre ha la convinzione incrollabile di essere infestato da parassiti: insetti, vermi, acari, microrganismi di vario tipo. Ogni paziente costruisce attorno a sé una narrazione precisa, spesso dettagliatissima, che prescinde da qualsiasi evidenza medica o dermatologica. È la Sindrome di Ekbom, un disturbo psichiatrico complesso, la cui diagnosi è difficile e il trattamento ancora di più, perché il paziente rifiuta qualsiasi spiegazione che non sia fisica.
Cos’è la Sindrome di Ekbom
La sindrome di Ekbom prende il nome dal neurologo svedese Karl Axel Ekbom, che nel 1938 ne delineò per la prima volta i tratti clinici in modo sistematico. «Tuttavia, le sue radici storiche affondano molto più indietro nel tempo», racconta la dottoressa Alessandra Ricco, psicologa clinica, psicoterapeuta e psicodiagnosta al San Pier Damiano Hospital di Faenza – GVM Care & Research. «La prima descrizione di un caso simile risale al 1843, quando una paziente riferì con convinzione di essere infestata da insetti che credeva di aver ingerito».
Nei decenni successivi, sono emerse varie segnalazioni di persone ossessionate dall’idea di avere malattie parassitarie come la scabbia, seppure in assenza di riscontri medici oggettivi. È stato proprio Ekbom a riconoscere per la prima volta questa condizione come una sindrome distinta, caratterizzata da un delirio persistente di infestazione.
Conosciuta anche come delirio da infestazione, parassitosi delirante o delirio dermatozoico, la sindrome di Ekbom è oggi classificata come un disturbo psichiatrico raro e complesso, spesso difficile da diagnosticare e trattare, soprattutto per la totale convinzione del paziente circa la natura organica dei suoi sintomi.
«La Sindrome di Ekbom rientra nel campo dei deliri somatici, una sottocategoria ben definita all’interno del DSM-5, il manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali», evidenzia l’esperta. «Più precisamente, si tratta di un disturbo delirante a contenuto somatico, che fa parte del più ampio spettro delle psicosi. In questi casi, il nucleo del delirio è centrato sul corpo: il soggetto è fermamente convinto di essere affetto da una condizione fisica, in questo caso un’infestazione parassitaria, nonostante ogni evidenza medica la smentisca».
Quali sono i sintomi della Sindrome di Ekbom
I sintomi riferiti sono principalmente sensoriali e coinvolgono quasi sempre la pelle: prurito, bruciore, formicolii, punture. La sensazione è quella di qualcosa che si muove, striscia o scava sotto la cute. In alcuni casi, però, i parassiti vengono percepiti in altre zone del corpo, come gli occhi o il tratto urogenitale. «A questa sintomatologia si associano spesso comportamenti compulsivi nel tentativo di “disinfestarsi”, come lavaggi continui, disinfezioni ossessive, uso di pinzette, aghi o oggetti appuntiti per cercare di rimuovere i presunti organismi», descrive la dottoressa Ricco. «Molti arrivano a provocarsi ferite nel tentativo di “estrarre” i presunti parassiti oppure raccolgono “prove” da mostrare ai medici: frammenti di pelle, polvere, capelli o tessuti che, nella loro percezione alterata, sono testimonianza dell’infestazione in atto».
La gravità dei sintomi varia da persona a persona, ma ciò che accomuna tutti i casi è la tenacia del delirio: il paziente è convinto, al di là di ogni ragionevole dubbio, che il problema sia reale. «Proprio questo rende la sindrome così difficile da diagnosticare e trattare», ammette l’esperta, «perché la sofferenza è vera, anche se la sua origine è mentale, e spesso il paziente rifiuta categoricamente qualunque ipotesi di natura psicologica o psichiatrica».
Come si diagnostica
La diagnosi della sindrome di Ekbom è clinica e richiede un approccio complesso, basato su un’attenta osservazione, un dialogo approfondito con il paziente e un’accurata raccolta anamnestica. «Non esistono esami strumentali in grado di identificarla direttamente», tiene a precisare la dottoressa Ricco, «ma è fondamentale escludere ogni possibile causa organica o dermatologica reale, come infestazioni cutanee (scabbia, pediculosi), allergie o altre dermatosi. Si parla infatti di diagnosi differenziale, un processo che in presenza di sintomi simili o sovrapponibili, permette di escludere gradualmente di altre ipotesi plausibili, fino a individuare la corretta diagnosi».
Spesso i pazienti cambiano medico più volte, nella speranza di trovarne uno che prenda sul serio il loro problema senza negarlo, sminuirlo o liquidarlo come un disturbo mentale. «Di fronte a esami negativi e diagnosi rassicuranti, si sentono incompresi o addirittura maltrattati, vivendo ogni smentita come un attacco personale», specifica l’esperta.
Di conseguenza, il percorso che conduce a una presa in carico psichiatrica è lungo, doloroso e pieno di ostacoli. Quando finalmente si arriva a considerare l’ipotesi di un delirio somatico, è spesso dopo mesi o anni di consulti, esami e frustrazioni. Solo a quel punto, con estrema gradualità e delicatezza, è possibile proporre un trattamento che unisca un intervento farmacologico (per contenere i sintomi deliranti e comportamentali) a un supporto psicologico o psicoterapico che aiuti il paziente a prendere consapevolezza, affrontare e rielaborare la propria esperienza, senza sentirsi invalidato o giudicato.
Quali sono le cause della sindrome di Ekbom
Le cause della sindrome di Ekbom restano un terreno di grande incertezza clinica. Non esiste un’unica origine certa, né un modello eziologico chiaro e condiviso: «Quello che sappiamo è che si tratta di un disturbo multi-causale, dove fattori psichiatrici, neurologici, organici, farmacologici, psicologici e perfino sociali possono concorrere, in modo variabile, all’insorgenza del quadro», commenta l’esperta.
Tra le ipotesi più frequenti, troviamo l’associazione con patologie psichiatriche gravi, come i disturbi psicotici e deliranti, ma anche con depressioni maggiori accompagnate da sintomi psicotici, disturbi ossessivo-compulsivi o d’ansia. A volte, però, il delirio dermatozoico si manifesta come disturbo primario, cioè isolato, senza una diagnosi psichiatrica conclamata: in questi casi, è ancora più difficile stabilire un’origine certa, e si rende necessario esplorare in profondità la struttura di personalità e la storia personale dell’individuo.
«In questo contesto, viene spesso chiamato in causa il trauma psicologico, ma con la dovuta cautela», dice la dottoressa Ricco. «Talvolta si possono effettivamente riscontrare nella storia personale eventi traumatici, anche lontani nel tempo o non pienamente consapevoli, che sembrano aver contribuito a un “somatizzazione estrema” del disagio psichico». Tuttavia, non esiste una correlazione lineare e diretta tra trauma e sviluppo della sindrome: il trauma può essere uno dei fattori in gioco, ma non è né necessario né sufficiente.
Non mancano anche possibili cause neurologiche, come le demenze – per esempio quella di Alzheimer – o danni cerebrovascolari. Alcuni pazienti sviluppano la sindrome in seguito a eventi degenerativi del sistema nervoso oppure come effetto collaterale di carenze nutrizionali, patologie sistemiche o intossicazioni. Esistono infine quadri clinici legati all’uso o all’astinenza da sostanze come cocaina, alcol o farmaci, che possono generare stati confusionali, allucinazioni somatiche e sintomi psicotici.
Come si cura la sindrome di Ekbom
Il trattamento deve necessariamente essere articolato e condotto da un’équipe multidisciplinare. La psichiatria ha un ruolo centrale, con terapie farmacologiche mirate – antipsicotici, antidepressivi o altri stabilizzatori dell’umore – da calibrare in base alla gravità e alla specificità del quadro clinico. Tuttavia, i farmaci da soli non bastano. «Servono anche il supporto psicologico, l’intervento del medico di base come figura di raccordo e una collaborazione continua con dermatologi, neurologi e altre figure, quando le somatizzazioni coinvolgono più distretti corporei», specifica la dottoressa Ricco.
Il problema più frequente è che il paziente tende a rifiutare sia la diagnosi sia il trattamento proposto. Il coinvolgimento psicoterapico – fondamentale per lavorare su consapevolezza, accettazione e gestione del disagio – è spesso ostacolato dalla rigidità della convinzione delirante. Chi è convinto di avere una patologia fisica difficilmente si affida a uno psicologo. Intanto, però, i sintomi si estendono: la vita sociale e lavorativa viene compromessa, i rapporti familiari e affettivi diventano tesi, la quotidianità si trasforma in un susseguirsi di rituali ossessivi, ipervigilanza corporea, episodi di ansia, isolamento e, nei casi più gravi, paranoia. C’è chi arriva a pensare che la “contaminazione” sia arrivata da qualcuno o che possa essere trasmessa ad altri.
Pur partendo da un sintomo monosintomatico, la sindrome invade progressivamente la vita del paziente, con un effetto a spirale che coinvolge e compromette funzioni cognitive, equilibrio emotivo, capacità relazionali. È un vortice che si allarga sempre di più, rendendo urgente un trattamento che sia non solo medico, ma anche umano, integrato e continuativo.
«Il trattamento ideale è dunque integrato, continuativo e condiviso tra le varie figure specialistiche coinvolte», conclude la dottoressa Ricco. «Più che una “guarigione”, l’obiettivo è costruire un equilibrio più stabile e sostenibile, una nuova narrazione di sé e del proprio vissuto corporeo, in cui il paziente possa tornare a vivere con minore angoscia, ansia e isolamento. Si lavora per contenere il più possibile la sofferenza che, per quanto percepita e non oggettiva, è reale, profonda e merita ascolto, rispetto e accoglienza».
Fai la tua domanda ai nostri esperti